Nel “De Rerum Natura”, scritto durante l’era repubblicana e riscoperto solo nel Quattrocento, Lucrezio mette in scena la descrizione della peste di Atene del 430 a.C.: il quadro è deliberatamente desolante e porta i tratti mitici dell’indefinitezza spazio-temporale che caratterizza le epoche crepuscolari. Caduti definitivamente i soggetti e gli orizzonti spazio-temporali, ciò che rimane è un tetro quadro di morte dalle forme spettacolari e macabre, che nondimeno l’autore sfrutta per veicolare una critica etica, facendo uso di un lessico solennemente ricco d’arcaismi, capace di sondare luoghi inesplorati dell’animo umano e della parola stessa.
di Salvatore Di Domenico
(revisione: Marco Maculotti)
copertina: John Martin, “La distruzione di Pompei ed Ercolano”, 1821
Il De Rerum Natura è un vasto compendio didascalico in versi sul funzionamento dei fenomeni naturali, dal magnetismo ai simulacra dell’amore, dal volgere dei cieli negli accadimenti atmosferici al mutare di condizione dell’animo umano. L’opera è composta di sei libri il cui contenuto era inviso alla dottrina cristiana, al punto che nel Medioevo l’opera lucreziana non fu trascritta e dunque rischiò di perdersi irreparabilmente. Perché il De Rerum Natura suscitava il timore dei difensori della cristianità? È presto detto: Lucrezio si proponeva, tra le altre cose, di disvelare gli ingannevoli aspetti dell’esistenza e di mettere in guardia gli uomini rispetto alla vanità del tempo, delle ansie come delle speranze, in un’ottica apertamente epicurea e incompatibile con la visione escatologica che contraddistinse il cristianesimo medievale. Per di più, Lucrezio giunse ad attribuire ad Epicuro, neanche troppo velatamente, un ruolo addirittura messianico, che avrebbe potuto essere letto, a posteriori, come dicotomico rispetto a quello del Cristo.
Il testo venne riscoperto soltanto nel 1417, rimanendo dunque nel dimenticatoio della storia per oltre un millennio, essendo stato composto al culmine dell’età repubblicana, nel I sec. a.C. È questo uno dei motivi per cui l’opera porta con sé un alone di mistero, ulteriormente accentuato dalla quasi totale mancanza di testimonianze biografiche sull’autore. A curare l’edizione del De Rerum Natura fu Cicerone che, pur diffidando dal suo autore in pubblico, in una lettera privata che ci è giunta lo elogiava. Altri tra i più grandi scrittori latini (Stazio, Quintiliano, Ovidio) ne elogiano lo stile, ma nessuno ne commentò adeguatamente il contenuto. Ciò suggerisce che Lucrezio fosse in realtà già inviso e “pericoloso” per i contenuti del suo libro già al suo tempo, prima dunque dell’avvento del cristianesimo, tanto che Ivano Dionigi parlò di lui come di un «poeta sprotetto come lo fu Dante» (che per motivi storici non lesse mai Lucrezio), individuando alcune analogie e differenze tra i due, entrambi definiti «poeti cosmici, poeti della salvazione e della conoscenza», benché posizionati su «poli teologici opposti».
Lucrezio, come detto, scompare in età teocratica. Tra i meriti che gli devono essere riconosciuti vi è quello di aver tentato — in un’epoca florida ma prossima al declino delle guerre civili e già priva dei suoi dèi, dove si allentano le forti imposizioni del potere religioso — di disincantare le immagini usate dalla politica per controllare le masse. Quella lucreziana allora si può considerare alla stregua di una rivoluzione che si pone come obiettivo primario l’abbattimento di quel connubio tanto dannoso tra religione e politica e la decostruzione del sistema di controllo teocratico per mezzo del sapere scientifico (al punto che, forse troppo fantasiosamente, alcuni critici moderni ne vollero ravvisare addirittura un marxismo ante tempora, con riguardo all’anelito della liberazione del proletariato dal giogo del potere religioso, «falso e scellerato nella richiesta dei sacrifici»).
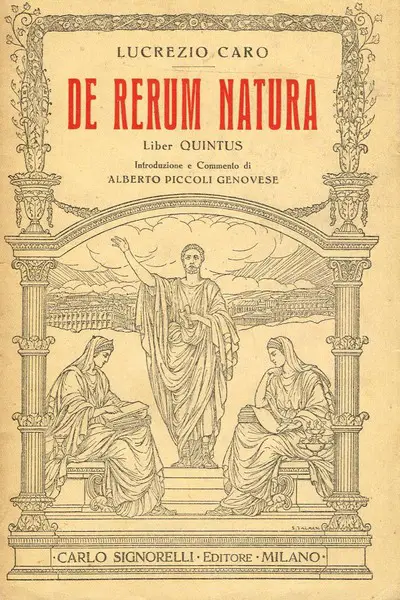
⁂ ⁂ ⁂
Uno dei motivi per cui mancano quasi del tutto notizie sulla vita dell’autore si può ravvisare nel suo quasi totale disinteresse per la vita mondana e politica della città, in ciò perfettamente ligio alla massima epicurea del «vivi nascosto». Alcune notizie, comunque, ci sono riportate quasi cinque secoli dopo la sua morte da San Girolamo nel Chronicon del IV d.C. Il santo, additando Lucrezio di un materialismo iconoclasta, accenna al fatto che il poeta soffrisse di una particolare follia, descritta come qualcosa che oggi chiameremmo disturbo bipolare:
« […] nasce il poeta Tito Lucrezio, che in seguito, impazzito per effetto di un filtro d’amore, dopo aver scritto negli intervalli di lucidità della follia alcuni libri, che poi Cicerone rivide per la pubblicazione, si uccise di propria mano all’età di 44 anni. »
Ma quest’ultima informazione difficilmente risponde al vero, essendo San Girolamo l’unico a riportarla. Si può anche dare adito a certe teorie per le quali, perdendo la protezione del mecenate Memmio (a cui l’opera è dedicata), Lucrezio sarebbe caduto in disgrazia e avrebbe scelto il suicidio per motivi politici — avvenimento, questo, d’altronde non raro nella storia romana.
Oltre queste congetture ipotetiche e ardue, comunque, è da notare come spesso si sia tentato di giustificare il finale enigmatico e complesso del De Rerum Natura con la teoria della follia dell’autore e le scarse conoscenze antiche delle cause dei disturbi psichici. A quanto pare, tuttavia, Lucrezio curava tali suoi supposti disturbi con la filosofia e con la scrittura, mantenendo così uno stato di lucidità elevato, tanto che ad alcuni piace paragonare la sua follia “lucida” con quella che contraddistinse, molti secoli dopo, il Tasso.
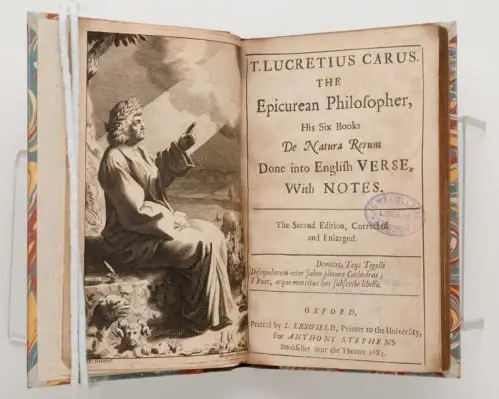
⁂ ⁂ ⁂
Nondimeno, se alcuni ritengono il De Rerum Natura un’opera incompiuta, altri vedono nel finale un messaggio di profonda potenza ermetica: l’opera termina con circa duecento versi che descrivono gli accadimenti immondi e osceni della peste di Atene del 430 a.C. A tal fine Lucrezio si ispira al modello di Tucidide, denotando tuttavia una maggiore ricercatezza psicologica, con la quale riesce a mettere in evidenza le conseguenze della malattia sui comportamenti squilibrati dei “mortali” già malati nell’animo, pregiudicando in tal modo il benché minimo spiraglio di guarigione, che invece in Tucidide sussiste fino all’ultimo.
All’inizio dell’ultimo libro, il VI, nell’elogio di Epicuro l’autore racconta di come gli uomini conducessero ormai delle vite scevre da qualsivoglia preoccupazione, con «la tavola preparata» e lo stomaco sempre pieno, crogiolandosi nel bieco orgoglio di vedere la propria discendenza affermarsi socialmente e godendo mollemente dei beni accumulati; per poi concludere paragonando l’animo umano a un vaso corrotto (ovvero forato e incapace di adempiere la sua funzione) e sporco, capace di tramutare le cose buone in guaste. Così i versi 9-23, qui nella traduzione (seppur datata) di Pietro Parrella:
« Egli [Epicuro] scorse che, tutto essendo ai mortali già dato
per i loro bisogni, potendo abbastanza sicura
essi menar la vita, di fama, d’onor, di ricchezze
andar fieri e potenti, goder de la lode dei figli,
pur ne l’intimo petto recavano tutti confitte
spine d’affanni, e invano d’assidue cure ansiose
si tormentavano lo spirto, costretti a lamenti crudeli.
L’uomo stesso, egli disse, ne ha colpa, ché in esso si guasta
come in corrotto vaso, quel ch’entro vi penetra e scende,
anche se buono: in parte perché mal connesso e forato
mai non si lascia empire, in parte perché di suo sporco
fetido lezzo tutto contamina quel che v’è chiuso. »

Come si evince dal passo, gli uomini subivano egualmente una anxia cordi («ansia del cuore, dello spirito») che, nascosta dietro le convenzioni sociali e le maschere che si avvicendano sul palcoscenico dell’esistenza esteriore, sarebbe in realtà destinata a covare in maniera più o meno latente, per esplodere poi nel grande dramma collettivo che causa per così dire la “rottura degli argini psichici” (nell’opera lucreziana, la peste di Atene). Così facendo l’autore individua la tematica esistenziale della sua opera: ponendo l’attenzione non tanto agli alti ideali astratti della virtus quanto a quelli terreni della precarietà, sottintendendo a più riprese come l’animo umano sia, de facto, perennemente insidiato da desideri indefiniti o irrealizzabili (esplicitati nel libro III).
A causa di un così oscuro orientamento filosofico, in certe critiche moderne si è parlato di Lucrezio come di un «poeta dell’angoscia» o di un «poeta maledetto», dovendosi tuttavia sottolineare anche un’interpretazione di segno opposto facente leva sull’immagine lucreziana di «scrittore luminoso» (di lucida carmina), razionale e materialista, che si giovò dell’adesione alla dottrina di Epicuro per denunciare il fatto, per lui incontrovertibile, che tutte le ansie umane proverrebbero unicamente dalla paura: paura della morte, degli dèi, del luogo ultraterreno; paura che è mancanza di razionalità, o di luce, nella nostra attitudine alla vita.
Troviamo allora molto difficile non collegare tale anxia cordi con i simulacra religiosi con i quali l’uomo inganna l’uomo: in questo senso quella lucreziana è poesia di liberazione della massa dal potere soggiogante della religione o — dunque — della paura. A riguardo di ciò, si può citare come Cicerone scrivesse che gli aruspicina, ovvero coloro che facevano previsioni interpretando il volo degli uccelli nel cielo, dopo aver letto i movimenti e i versi di un avvoltoio o di una cornacchia o di altri uccelli, e dopo aver dettato al popolo le prescrizioni a cui avrebbe dovuto adeguarsi, talvolta, dopo essersi ritirati lontano da occhi indiscreti, essi ridessero compiaciuti della creduloneria del dèmos.

⁂ ⁂ ⁂
Forse anche per questa ragione il libro VI (da alcuni studiosi denominato «libro metereologico») prosegue con la spiegazione di fenomeni atmosferici e geofisici — come tempeste e arcobaleni, maree e terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni fluviali — volta a sbugiardare, con i mezzi discorsivi propri dell’epicureismo, le credenze incentrate sulla superstizione, irridendo chi crede all’immagine antropomorfa di Giove che, dalla sua sede olimpica, scaglia fulmini e tuoni e lampi sulla superficie terrestri, fenomeni per i quali esisteva già al tempo una dettagliata spiegazione fisica.
Durante l’epoca apicale della Repubblica, anni in cui Lucrezio scriveva, alle soglie storiche dell’impero, suddette pratiche superstiziose si configuravano forse come mai prima come mero strumento di potere. Nei tempi antichi, va ricordato, le conoscenze tecniche e scientifiche erano divulgate all’interno di ambienti segreti dal sentore iniziatico (così come accadde in origine con la stessa scrittura), di modo che chi possedeva tali conoscenze, talvolta indispensabili per la sopravvivenza stessa (si pensi a quanto potesse essere utile saper distinguere una pianta velenosa da una commestibile, o banalmente saper riconoscere gli strumenti per accendere un fuoco), potesse sfruttare tali informazioni e tecniche per ottenere e consolidare certe forme di potere rispetto a chi, al contrario, le ignorava. (È, d’altronde, ciò che al giorno d’oggi si ritrova in ambito economico con la denominazione di «asimmetria informativa», condizione in cui un’informazione non è condivisa integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico; conseguentemente, una parte degli agenti interessati dispone di maggiori informazioni rispetto al resto dei partecipanti e può trarre un vantaggio da questa configurazione).
Inoltre, nota Lucrezio, con i continui mutamenti che si registrano nel mondo del Divenire mutano anche i termini dell’anxia cordi di cui si è detto (almeno nel suo reale declinarsi, se — a ragione — si vuole ritenere l’anxia cordi umana la medesima in tutte le epoche): questa sorge in primo luogo dal soddisfacimento dei bisogni naturali e primitivi e dall’ottemperanza automatica alle tendenze istintuali (come poteva essere il procurarsi o produrre del cibo o delle vesti o, ancora, il procreare). Si giunge allora a non riconoscere più i bisogni reali e primari come fondamentali, bensì come dovuti o già dati; e, dunque, quelli secondari come necessari. Tra i meriti che vanno riconosciuti a Lucrezio c’è anche questo: l’aver saputo smascherare questo inganno, accorgendosi che i bisogni che l’uomo reputa necessari in realtà non lo sono, anzi al contrario, laddove pienamente soddisfatti, lo allontanerebbero irrimediabilmente dall’immanenza della vita, ovvero da ciò che unicamente ha il potere di renderla un’esistenza autentica.

⁂ ⁂ ⁂
Con queste premesse, Lucrezio mette in scena la descrizione della peste di Atene. Il quadro è deliberatamente desolante e porta i tratti mitici dell’indefinitezza spazio-temporale che caratterizza le epoche crepuscolari. Caduti definitivamente i soggetti e gli orizzonti spazio-temporali, ciò che rimane è un tetro quadro di morte dalle forme spettacolari e macabre, che nondimeno l’autore sfrutta per veicolare una critica etica, facendo uso di un lessico solennemente ricco d’arcaismi, capace di sondare luoghi inesplorati dell’animo umano e della parola stessa.
Innanzitutto accenna generalmente ai morbi che gravano sul mondo intero, a seconda dei diversi climi delle varie parti del globo terracqueo; quindi passa a menzionare quelli specifici che colpiscono generatim, cioè «a seconda della specie»: così, gli Egiziani soffrivano di elefantiasi (ispessimento cutaneo), gli Attici si ammalavano spesso ai piedi e i Greci agli occhi. Poi descrive come, anche senza il contatto fisico con il portatore del morbo, nuvole d’aria infetta possano estendere la sua diffusione in modo indiscriminato:
« Tal di pestiferi germi ondata, tal flusso letale
Nella Cecropia terra un giorno attoscò le campagne,
rese mute le strade e prive di gente le case.
Trasse il contagio sua prima origine in fondo all’Egitto;
indi, gran tratto d’aria percorso, sui piani del mare
sorvolando, ristette al fine sul popolo tutto
di Pandione: infetti perivano gli uomini a torme. »
Successivamente si sofferma sui sintomi e li elenca, calcando in parte il modello di Tucidide: prima il morbo prende alla testa, che si accalda; poi gli occhi arrossiscono e la gola suda sangue. La voce allora lentamente si estingue e la lingua stillata di sangue, interprete dell’animo («messaggera dell’alma»), si fa pigra e scabra. La mente perdeva ogni raziocinio e i malati gemevano al suolo, devastati da un singhiozzare continuo. Benché a toccarli si sentisse solo un lieve tepore, gli ammorbati sentivano la pelle cosparsa di ferite bruciare a tal punto da non poter sopportare nemmeno un velo sottile; e con la medesima intensità ardevano anche gli organi interni. Gli infetti compivano meccanicamente movimenti spasmodici che ne logoravano i nervi fino allo sfacelo definitivo, segno rivelatore di una «soffocante angoscia» (anxius angor) che li conduceva implacabilmente verso la morte.

⁂ ⁂ ⁂
Il passo lucreziano non si astiene dall’indagare la dimensione psicologica, dilatata follemente dall’atmosfera di disperazione collettiva che accompagnava il dipanarsi degli eventi, procedendo a un elenco degli atti di follia che conseguirono al contagio fisico: smaniosi di freddo e di vento i malati accorrevano per gettarsi nei pozzi o nei fiumi, pur senza trovare sollievo, talvolta morendo, e con occhi infiammati e stanchi chiedevano aiuto, ma non vi era farmaco che funzionasse; a peggiorare la situazione, il farmaco che salvava qualcuno altri uccideva e non v’era un rimedio che funzionasse per tutti. Le visioni di morte prendevano allora il sopravvento:
« Tregua il mal non aveva: giacevano, esausti di forze,
senza moto, gl’infermi. Volgevano questi, ansiosi,
occhi sbarrati, accesi dal morbo, ma chiusi pel sonno,
a domandare aiuto; ma, trepida e ignara, taceva
l’arte dei farmachi. Ed altri indizi apparivano allora
della morte imminente: sconvolta la mente, gravata
d’incubi e di tristezza […] »
Gli arti tremavano e il freddo si diffondeva in tutte le membra, un deperimento generale portava le tempie ad incavarsi e gli occhi ad infossarsi; nel giro di otto o nove giorni il morbo conduceva i malcapitati al decesso. Se il fisico di qualcuno resisteva alla virulenza della malattia, questa automaticamente si inaspriva e fiotti di sangue cominciavano a uscire anche dal naso; il morbo raggiungeva ogni parte del corpo e, con la chimera di evitare la morte, i contagiati ormai folli s’amputavano le mani o i piedi, o addirittura gli organi genitali. Alcuni obliavano ogni cosa e smarrivano del tutto la lucidità, regredendo ad uno stato di incoscienza totale.
Di più: la descrizione di Lucrezio non si limita agli uomini infetti, menzionando pure animali anch’essi fiaccati del male, che si trascinano morenti seminascosti nelle foreste. Ma soprattutto vengono analizzati gli effetti del morbo tra chi non ne era contagiato. Nella psicosi collettiva creata da uno stato permanente di terrore e pericolo, la gente non sapeva più reagire: chi, troppo bramoso di vita, rifuggiva tutti i cari per paura di ammalarsi, alla fine moriva a sua volta estraneo a ogni soccorso; il virtuoso che pur d’assistere i cari negli ultimi attimi si contagiava, spinto da un senso d’onore e dalla supplichevole voce dei moribondi, era destinato a seguirli subito nell’Oltretomba.
Morivano anche numerosi bambini, sui quali corpicini martoriati dal morbo si ammucchiavano i genitori; altrove, bambini ancora in tenera età seppellivano i padri. Dai campi confluì gran parte del contagio, che poi si riversò nelle città per «il denso accorrere d’infermi coloni da ogni già infetta zona». Chi non moriva per gli effetti del morbo, veniva fiaccato dalla povertà, che ovunque si diffondeva sempre più, parallelamente alla peste.

Anche gli dèi, privati definitivamente del culto, morivano e le pratiche venivano abbandonate, poiché persino i luoghi sacri erano contaminati dal morbo e dalla morte. Non si teneva più in onore il culto divino né c’era il timore dei numi; non si rispettavano più i riti di sepoltura e sulle cataste erette per i roghi di altri la gente metteva i propri morti, dando così vita a zuffe insensate.
Poi, il silenzio improvviso: così termina il De Rerum Natura. volendo ritenere il finale genuino — ovvero voluto dall’autore, e non “monco” –, si può individuare forse un punto di contatto con il modello omerico dell’Iliade, che pure finisce con un rito di sepoltura. Ma vi si può anche scorgere l’hysteron proteron (inversione cronologica degli eventi, inizio e fine) con cui Lucrezio chiude perfettamente il cerchio tematico riallacciandosi all’inizio dell’opera, suggerendone così una lettura circolare, coerente alla dottrina della ciclicità degli universi che andava di pari passo alla dottrina atomica epicurea. Ma, d’altro canto, ci sembra che questo finale disegni anche un mondo sordo e privo degli insegnamenti di Epicuro, lasciando aperta l’incombente necessità di reperirli, oltre a dimostrare la vanità di quegli “dèi” tanto facili a cadere.
⁂ ⁂ ⁂
Ci chiediamo a questo punto quale sia il senso profondo di un finale così fulminante, che tanto ha complicato, nella veduta d’insieme, l’articolazione delle predette posizioni critiche. A noi pare che Lucrezio per mezzo della descrizione così “viva” degli effetti della peste, voglia in qualche modo “normalizzare” o “umanizzare” la morte onde sconfiggerne il timor indelebilmente connesso alla sua innata impersonalità (vale a dire alla sua azione che compie in maniera indiscriminata e imprevedibile), distinguendosi in questo dal testo di Tucidide che, nel suo realismo cronachistico, sotto questo punto di vista appare paradossalmente più ansiogeno.
Ci pare inoltre che, così facendo, Lucrezio voglia in un certo modo prendere improvvisamente le distanze da se stesso e dal suo insegnamento (ecco dove alcune critiche vedono la follia o il bipolarismo dell’autore), cedendo, in appendice all’esposizione filosofica e scientifica ispirata ai princìpi di Epicuro, a una commozione suggestivamente patetica (nel senso di “ricca di phatos”) e malinconica, quasi a ricordare con improvvisa lucidità l’effimera vanità dell’universo, che in nessun altro modo può concludersi se non con la morte, che conduce ogni cosa manifestata indietro nell’immanifesto.

Il richiamo dell’«inestinguibile sete» con la quale si definisce sia l’Amore nel libro IV che la ricerca continua di vento e di fresco da parte degli ammorbati nel VI rende il tema della peste e quello dell’amore speculari, e dunque non separabili dal punto di vista dell’anxius angor, l’«affannosa angoscia», vero e proprio morbo psichico connaturato al genere umano, che prende proteicamente varie forme all’interno dell’eterogeneità dell’esperienza umana. Amore e morte si collocano in questo modo sullo stesso piano: innamorato e appestato sono simili nella rispettiva «inestinguibile sete» che li contraddistingue come un marchio a fuoco.
Come ultima nota di disincanto ci preme infine sottolineare come Epicuro affermi essere il suo insegnamento dei pochi e non dei molti, così come probabilmente Lucrezio riteneva per pochi “coraggiosi” la sua stessa opera: i più preferiscono lasciarsi cullare da favole ben congegnate da chi di dovere per mantenere le masse nel quieto vivere e colmare le proprie angosce esistenziali con l’ausilio di falsi dogmi e credenze superstiziose. A tal proposito vogliamo concludere questa nostra analisi con alcune citazioni riportate da Seneca nelle Lettere a Lucilio:
« Scrive Democrito: “Secondo me, una sola persona vale quanto tutto il popolo e il popolo quanto una sola persona.” Dice bene anche quell’altro, chiunque sia stato (è incerto, infatti, di chi si tratti); gli chiedevano perché si applicasse con tanto impegno a una materia che pochissimi avrebbero compreso, [e quegli] rispose: “A me bastano poche persone, anzi anche una sola o addirittura nessuna.” Eccellente anche questa terza affermazione, di Epicuro; in una sua lettera a un compagno di studi: “Io parlo non per molti, ma per te;” scrive, “noi siamo l’uno per l’altro un teatro sufficientemente grande.” […] perché [Lucilio] dovresti rallegrarti se sono in tanti a capirti?” »
Cosi, ci piace pensare che nel finale del De Rerum Natura si possa leggere tra le righe anche questo approccio con cui Seneca si poneva nei confronti del suo interlocutore epistolare, e che Lucrezio sembrerebbe rivolgere direttamente al lettore:
« Io non scrivo per i molti, ma per te, che, giunto fino alla fine, ora osservi la follia degli uomini. »
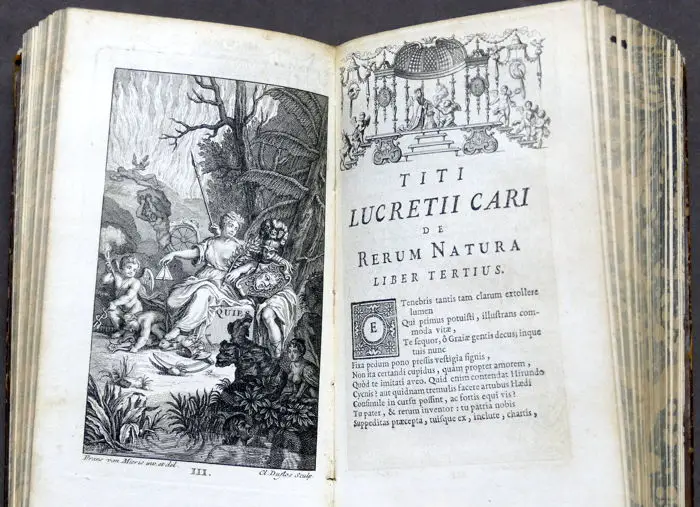

3 commenti su “La peste e i simulacra del controllo sociale nel “De Rerum Natura” di Lucrezio”