Nella silloge “Indomite. Storie di coronate e di bestie”, pubblicata da Vocifuoriscena, si trova un’eco della migliore Sylvia Townsend Warner, tra foreste, dee cacciatrici, baccanti, re e regine. Un aggiornamento contemporaneo di letteratura stregonesca a metà strada tra il “racconto crudele” e la “fiaba nera”.
di Paolo Mathlouthi
“…donne che da terre straniere ho portato con me,
Euripide
Mie complici e compagne di strada”.
In una celeberrima intervista rilasciata nel 1977 ad Alberto Arbasino che, per spirito di contraddizione, lo incalzava sul tema del realismo, ipnotico mantra di quella che allora si chiamava cultura militante, Jorge Luis Borges rispondeva lapidario che la letteratura o è fantastica oppure, semplicemente, non è.
“Il realismo – precisava – è solo un episodio. Nessuno scrittore ha mai sognato di essere un proprio contemporaneo. La letteratura ha avuto origine con la cosmogonia, con la mitologia, con i racconti di Dèi e di mostri”.
La scellerata idea, oggi tanto in voga, che la scrittura serva a monitorare la realtà, con le sue contraddizioni e i suoi rivolgimenti effimeri è una stortura, una demonia connaturata al mondo moderno, una malattia dell’anima che in questi anni ha permesso a scrittrici improvvisate pubescenti d’intrattenere torme di lettori, descrivendo con morbosa puntigliosità le proprie avventure sessuali tra un colpo di spazzola e l’altro. Per fortuna c’è ancora chi, all’alba del XXI secolo, dimostra di muoversi con orgogliosa consapevolezza in direzione ostinata e contraria, sposando la lezione del grande argentino. È il caso, tanto più prezioso proprio perché raro, di Simona Friuli che per la neonata casa editrice viterbese Vocifuoriscena, particolarmente sensibile alle diverse forme attraverso le quali il Fantastico s’incarna nella parola, ha licenziato una folgorante raccolta di racconti d’argomento stregonesco intitolata Indomite.
Allieva di Calliope, la giovane scrittrice sa che è la Musa a dischiudere il terzo occhio del Poeta ed alimentare il sacro fuoco dell’ispirazione. Scrivere è una pratica umana che ha una strettissima correlazione con il divino, è il riverbero dell’infinito sul finito come avrebbe detto Kant, il solo modo concesso ai mortali per intravedere Dio (o il Diavolo, che è poi il lato in ombra del medesimo). Erigere cattedrali di luce per illuminare l’oscurità, spargere dei draghi il seme, gettare le proprie arcate oltre il mondo dei sogni secondo l’ammonimento di Ernst Junger: questo sembra essere il compito gravido di presagi che l’Autrice intende assegnare al periglioso esercizio della scrittura. Opporre alle umbratili illusioni del divenire la granitica perennità dell’archetipo, attingere alle radici del Mito per far sì che l’Eterno Ritorno possa compiersi di nuovo, a dispetto del tempo e delle sue forme cangianti.
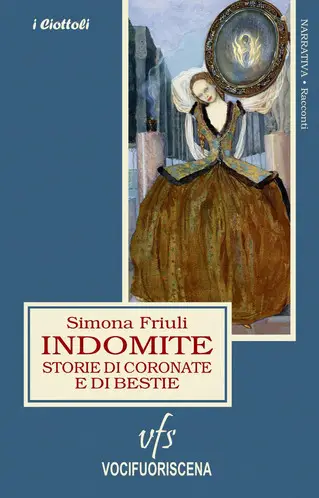
Ed è appunto di archetipi (non se ne abbia a male il buon Sigmund Freud) che in queste ferine, spietate novelle “di coronate e di bestie” si discetta con dotta, ricercata consapevolezza, volentieri indulgendo ad un legittimo, divertito autocompiacimento. Al centro della trama, una Foresta: luogo pericoloso, primordiale, spazio sacro per antonomasia deputato all’incontro dell’uomo con il sovrannaturale, inespugnabile recesso dove “neppure osano gli astri mettervi luce” che inestricabile s’innalza a perenne testimonianza di ciò che, improvvidi e scellerati, abbiamo smarrito insieme all’infanzia del mondo.
Bandita dal cielo, una Dèa cacciatrice vi trova dimora in forma di Donna. Sembra quasi di vederla, la Velenosa, slanciata e statuaria muoversi nel folto della boscaglia, pienamente a suo agio in quella frondosa, rassicurante oscurità che le offre complice riparo dagli strali della gelosa potestà paterna. Austera ed eretta nel portamento, snella, sinuosa e letale come una giovane pantera saetta tra i rami all’inseguimento dell’ansimante preda, scoccando una freccia per far sanguinare il vento.
Altre figure le fanno corona, a lei consacrate dal vincolo segreto e indissolubile di una profonda, carnale consanguineità, la stessa che unisce le affiliate ad una congrega di baccanti: la Rossa, la Mezzana, la Buia, la Fredda, la Spinosa. Nomi diversi per altrettante esperienze di schiavitù infranta, atavico, incancellabile stigma di una femminilità imperiosa, forsennata, vaticinante, “non domabile a vezzeggi o carezze” e irriducibile ai vincoli di una Legge farisaica, quella repressiva connaturata all’esercizio del Potere, attributo specifico del mondo maschile che, arroccato in sussiegosa difesa delle proprie prerogative sociali, vorrebbe queste Erinni fameliche e furiose necessariamente madri, figlie, spose o, alla meglio, concubine.

Al seguito della Dèa riscoprono invece una perduta familiarità con il mondo animale, la loro pelle si veste di corteccia, inghirlandate d’edera rinascono a nuova vita nel segno di una panica simbiosi con la Foresta, imparano ad ascoltare la voce della belva che alberga in loro da troppo tempo costretta in catene, ne assumono i tratti che la luce lunare disvela allo sguardo degli incauti in tutta la sua disperante terribilità. Ciascuna
“nelle cose crebbe di bosco, al petto portando mazzi di more e di rovo. Ebbe orecchie per sentire le bestie, se avvicinassero, e la caduta dei frutti, o dell’uomo i passi – bieco animale, più di ogni altro –, crepitando le foglie. Non ebbe bocca fatta a umane parole, ma con quella ululava o guaiva a seconda del suo bisogno. Imparò dalle fiere, perché di quelle era parte. Non era umana se non per il corpo che pure, alla vita selvosa aderì: le si allungarono gli arti, allungandosi il busto, e, forti, i denti le crebbero in bocca e tutta di fango brunì: con quello imitava le belve pelose. Quando la terra non più le bastò, apprese a togliere il vello alla morte, e a coprirsene, al bosco di più appartenendo. Non portava chiome acconciate, né oro su esse come le sarebbe spettato. A vestirla era la selva: il vento le guance di foglie adornava e nella chioma – groviglio seminava piume o piccole frutta, a seconda di dove sdraiava; e non si portava eretta, andando carponi. Per questo a Velenosa era cara: sunto aveva il latte dell’erba e, in quella che non era lingua, solennemente si giurò, sciolta come Tempesta di viver potente.”
[1]
Trasmutano le silvane adepte della numinosa sovrana e, a seconda dell’indole toccata loro in sorte, diventano lupe, tigri, volpi, pitonesse, aracnidi, assaporando la sanguinaria, incontenibile, spasmodica frenesia della caccia. Si palesano all’improvviso nella loro autentica natura di fronte agli uomini che, irretiti dal richiamo dei sensi, inconsapevoli cercano di prevaricarle e, implacabili come mantidi religiose, ne divorano le membra.
“Perché la Dèa ha gli occhi del basilisco, e in serpente si cambia – sinuosità azzurro-argento; antrace di squame. Corpo strisciante a corpo umano avvolgendo, lo strazia. […] ché la Serpentessa color di antimonio la testa ha piegato, e deflorandogli il collo coi denti, a sé serrandolo morde mentre sangue le liscia la lingua forcuta, e a quello sconcia, il veleno, le vene e la carne […]. Si arresta respiro mentre la Velenosa ritrae e, placata, morire lo guarda. La Foresta il cuore gli prende facendone polvere.”
[2]

L’incontro con la divinità, specie se selvaggia, non si addice in tutta evidenza agli ignavi e ai codardi, poiché non è mai senza conseguenze e sempre esige un pegno. Nella consumata eleganza con la quale Simona Friuli dimostra di saper maneggiare una materia pericolosa come quella dell’immaginazione mi compiaccio d’intravedere, peccando forse un po’ di presunzione (spero di non attirarmi le folgori dell’Autrice), un’eco della migliore Sylvia Townsend Warner, quella di Lolly Willowes per intenderci, dove l’ignara protagonista intraprende un percorso iniziatico di progressiva autoconsapevolezza che la porterà a celebrare arcane nozze nientemeno che con il Principe delle Tenebre in persona (libro quest’ultimo, ça va sans dire, caldamente consigliato).
Al pari dell’illustre antesignana inglese, maestra insuperata del racconto crudele tanto da meritare un attestato di stima da Theodore Francis Powys, critico impietoso perché maledettamente consapevole del proprio talento e quindi per nulla avvezzo a sciorinare complimenti gratuiti verso chiunque non fosse lui stesso, la scelta della fiaba quale habitus formale della narrazione, impreziosito da un linguaggio studiatamente desueto ed intessuto di pregiati arcaismi barocchi, non vuole essere semplice esercizio di stile, che pure non le fa certo difetto, ma cela anche in questo caso un preciso intento poetico. Accettare la realtà con i suoi spazi angusti significherebbe infatti per la talentuosa aspirante Driade ammettere la finitezza della condizione umana, abdicare alla convinzione secondo la quale le ragioni ultime dell’esistenza risiedono in un superiore disegno, rinunciare alla ricerca di un senso, un barlume di Verità al di là delle apparenze.
In questa prospettiva la “fuga” verso l’Altrove che la sua prosa ci offre non è un atto di diserzione, ma assomiglia piuttosto all’evasione del prigioniero a suo tempo evocata da Tolkien: spezzare le catene della contingenza per riguadagnare la perduta prossimità all’Origine, per riconquistare il nostro posto nell’Essere. Se, come sostengono gli stolti, il mondo cambia continuamente, l’Epos è sempre uguale a se stesso, perché parla il linguaggio dell’Eternità.
Note
[1] Simona Friuli, Indomite. Storie di coronate e di bestie, Vocifuoriscena, Viterbo, 2020; pag. 47- 48
[2] Ibidem; pag. 56
