Pittore allucinato ed immaginifico, artista poliedrico e visionario, costretto da continui crolli nervosi a prolungati soggiorni in case di cura e ospedali psichiatrici, Mervyn Peake affida proprio alla parola scritta il compito di esorcizzare le tenebrose ossessioni che alla fine lo divoreranno. Sul tempestoso mare di un universo onirico insieme nutrito e minacciato dagli eccessi di un’insania autodistruttiva, s’inarcano le arabescate, funamboliche architetture del castello di Gormenghast, mostruosa, aggrovigliata, ciclopica concrezione delle paure incontrollabili che attanagliano l’anima dello scrittore inglese.
di Paolo Mathlouthi
copertina: Marvyn Peake fotografato nel 1946
Esiste una correlazione tra Genio e Follia? Karl Jaspers, autore di un saggio diventato ormai un classico irrinunciabile sull’argomento, risponderebbe senza esitazione che l’uno non può esistere senza l’altra. Se l’attenzione del filosofo tedesco si concentra in modo particolare sulla figura di Van Gogh quale paradigma della sua argomentazione, la letteratura e la filosofia hanno offerto esempi non meno emblematici dell’irrefutabilità di questa dicotomia dialettica.
Le liriche di Holderlin avrebbero forse quella vertiginosa, vaticinante luminosità se il poeta, stretto d’assedio dalla pazzia, non avesse scelto di condannare se stesso al buio di un’esistenza claustrale? Dovstoevskij avrebbe scandagliato con la stessa chirurgica precisione le insondabili profondità dell’Abisso sull’orlo del quale si affacciano Raskol’nikov, Stravrogin e Goljadkin, suoi tormentati alter ego, se i ripetuti attacchi di epilessia non lo avessero obbligato ad un quotidiano confronto con i mostri che fanno vacillare le certezze della Ragione? Friedrich Nietzsche sarebbe stato folgorato dall’intuizione dell’Eterno Ritorno o avrebbe profetizzato la morte di Dio se l’insidioso demone del deliquio non si fosse impossessato della sua mente portentosa? I lettori sanno in cuor suo che la risposta a questi interrogativi è in realtà scontata.
Dall’antica Grecia alle glaciali solitudini della taiga siberiana, le culture tradizionali di ogni tempo e latitudine condividono l’idea che la pazzia sia una manifestazione del Sacro, un mezzo attraverso il quale le potenze ultraterrene offrono agli iniziati che ne sono colpiti, siano essi eroi oppure oracoli, la possibilità di accedere ad un diverso livello della coscienza e la scrittura, che da sempre intrattiene con il divino legami sotterranei, diventa esperienza liminale per antonomasia, principale chiave d’accesso a questo giardino segreto rigorosamente precluso ai profani [1].
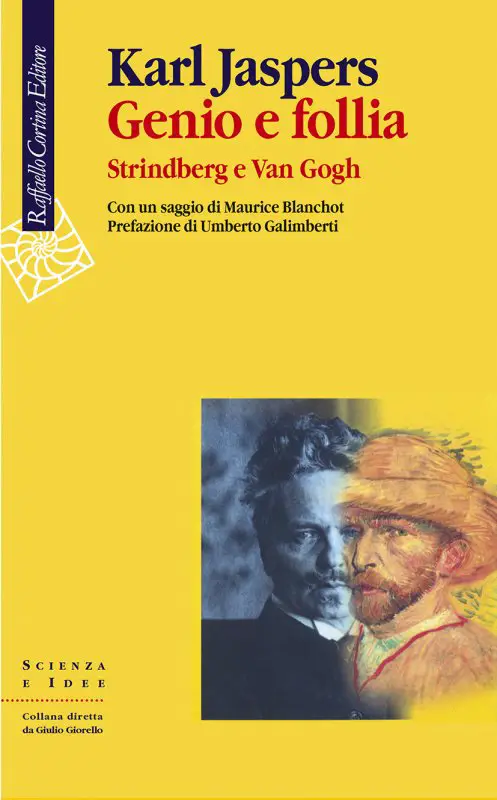

Pittore allucinato ed immaginifico, artista poliedrico e visionario, illustratore fantasioso dei capolavori di Lewis Carroll e Robert Louis Stevenson nonché della più nota edizione britannica delle fiabe dei fratelli Grimm, costretto da continui crolli nervosi a prolungati soggiorni in case di cura e ospedali psichiatrici, Mervyn Peake (1911 – 1968) affida proprio alla parola scritta il compito di esorcizzare le tenebrose ossessioni che alla fine lo divoreranno. Sul tempestoso mare di un universo onirico insieme nutrito e minacciato dagli eccessi di un’insania autodistruttiva, s’inarcano le arabescate, funamboliche architetture del castello di Gormenghast, mostruosa, aggrovigliata, ciclopica concrezione delle paure incontrollabili che attanagliano l’anima dello scrittore inglese, all’ombra della quale si consuma la tragica epopea dell’antico casato dei De’ Lamenti, legato da tempo immemorabile alle sorti del maniero nel quale vive avulso dalla realtà che incessantemente si agita oltre gli inespugnabili bastioni.
“Mura alte e sinistre come banchine di moli, o segrete per i condannati, svettavano nell’aria acquosa o curvavano maestose in archi prodigiosi di pietra crudele […]. Contrafforti e alte costruzioni incombevano come carcasse di navi sfasciate, o mostri marini dalle bocche e dalle fronti grondanti […]. Il castello si alzava sull’orizzonte come la gigantesca scogliera di un continente; un litorale rosicchiato da innumerevoli insenature e morso in profondità da baie ombreggiate. Un continente, con un assembramento di isole al largo delle coste; isole di tutte le forme che una torre può assumere; arcipelaghi interi; istmi e promontori; tetre penisole di pietra frastagliata – un panorama inesauribile, rispecchiato in ogni dettaglio dalle paurose profondità sottostanti […]. Sui tetti irregolari cadeva […] l’ombra del Torrione delle Selci che, pezzato qua e là di edera nera, sorgeva dai pugni di pietrame nocchiuto come un dito mutilato, puntando come una bestemmia verso il cielo.”
[2]
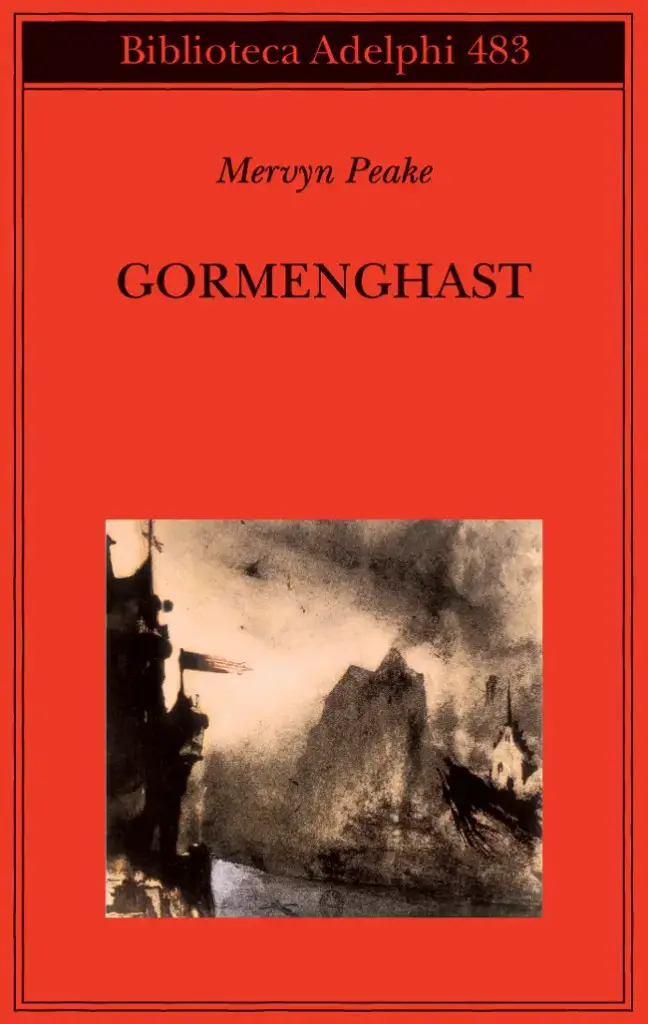
Proprio in questo luogo inaccessibile, elitario romitaggio riservato al culto delle memorie degli Antenati, in una notte rischiarata dai corruschi bagliori dell’incendio che avvampa nelle sale della biblioteca, trova la morte il Conte Sepulcrio che nel tentativo di sottrarsi alla morsa delle fiamme raggiunge il punto più alto del Torrione e viene aggredito dai gufi che vi si annidano, i quali ne dilaniano con efferata, vorace bramosia le carni precipitando il suo corpo nella scarpata sottostante. È un mondo claustrofobico quello descritto da Mervyn Peake nella sua monumentale trilogia, costellato di inestricabili labirinti, corridoi interminabili, segrete inviolabili, sotterranei recessi, dove un meticoloso rituale scandisce fin nei più insignificanti dettagli tempi e modi di una struttura sociale rigidamente gerarchizzata e non suscettibile di modificazioni al vertice della quale stanno i Maestri del Rito, Agrimonio e Barbacane, figure grottesche rese ripugnanti dalla tossica contiguità con il potere che nel nome richiamano alla memoria i Demoni danteschi accrocchiati sulle mura di Dite, esseri deformi e zoppi il cui lugubre passo, amplificato a dismisura dall’eco, riecheggia ad ogni piè sospinto sotto le volte del castello, preannunciando a chiunque il loro arrivo.
Presi dal panico, i dignitari riunitisi alla notizia della morte di Sepulcrio per manifestare il proprio cordoglio all’imperturbabile Contessa Gertrude e omaggiare con un atto di sottomissione il piccolo Tito, futuro erede al trono, cominciano a chiedersi come sia possibile che in un luogo in cui ogni fatto, ogni evento, ogni gesto, perfino le confidenze che con la complicità della notte i servi si scambiano sussurrando tra loro è ossessivamente vagliato e soppesato perché non infranga il complicatissimo cerimoniale, qualcuno possa aver attentato nientemeno che alla vita dell’autorità suprema. Gormenghast non è un sepolcro imbiancato, ma un “formicaio di pietra” dove senza posa brulica un’umanità in eterno subbuglio, resa folle dall’obbligo tassativo che impedisce a chiunque di abbandonarne i confini. La fortezza sembra essere dotata di un’oscura volontà propria, si nutre letteralmente della forza vitale di coloro la abitano e la convivenza forzata entro gli spazi angusti di un’esistenza claustrale condotta costantemente al riparo dalla luce del sole, alimenta giocoforza il dispiegarsi delle più torbide e oblique aspirazioni dell’animo.

Non stupisce quindi che nelle abissali, incandescenti profondità della Grande Cucina, un reietto, un paria come Ferraguzzo, coltivi in segreto bellicosi propositi di rivalsa sociale. Il fisico asciutto e vigoroso temprato dalle fatiche, la scarmigliata chioma rossiccia ad aureolare un cranio bombato dai tratti lombrosiani, due occhi spiritati e mobilissimi, attenti ad ogni impercettibile mutamento, il misconosciuto garzone si sottrae con uno stratagemma alle umilianti incombenze alle quali, secondo la ferrea logica che governa il maniero, lo incatenerebbero a vita le sue origini plebee, conquistandosi il favore del vanesio medico di corte Floristrazio il quale lo introduce nelle segrete stanze. È il segno di una mutazione alchemica che all’improvviso disvela la sua vera natura: appoggiato ad un bastone dall’anima armata, accompagnato da una scimmietta di nome Lucifero, l’intraprendente parvenu, protetto dalla benevolenza dei più influenti membri della corte, si adopera con febbrile, meticolosa solerzia in ogni angolo del castello, sempre preceduto dal lugubre presagio della sua ombra che, avvolgendolo come un mantello, giganteggia al chiaroscuro delle torce scivolando lungo le pareti e i colonnati dei chiostri. A chiunque lo incontri, voce suadente e fare ammiccante, dispensa consigli, offre aiuto, garantisce protezione e, con machiavellica astuzia, muove i vari attori di questo rutilante caravanserraglio barocco l’uno contro l’altro, come in una gigantesca partita a scacchi giocata da figuranti in carne ed ossa.
Seduce la giovane Fucsia, sorella di Tito, creatura agreste, spirito indocile e lunatico, soffia sul fuoco del risentimento che cova nel cuore delle gemelle Cora e Clarice, asprigne zitelle ostili a Sepulcrio che rimproverano di non volerle tenere nella considerazione dovuta al proprio rango e si serve di loro come esecutrici materiali dell’incendio nel quale il Conte troverà la morte, salvo poi rinchiuderle nella Sala delle Radici; uccide senza esitazione Agrimonio e Barbacane ritrovandosi infine unico depositario, custode e interprete delle leggi di Gormenghast. Una scalata al Cielo in piena regola, perseguita con lucida freddezza e spietata determinazione, alla quale solo il legittimo erede, vissuto fino a quel momento in volontario esilio nella Foresta dei Rovi sotto lo sguardo vigile dell’anziano Lisca, notabile della vecchia guardia rimasto fedele alla memoria di suo padre, potrà porre un freno, eliminando Ferraguzzo in uno scontro all’ultimo sangue che, ripristinando la linea di successione, ristabilirà il coretto ordine degli eventi.
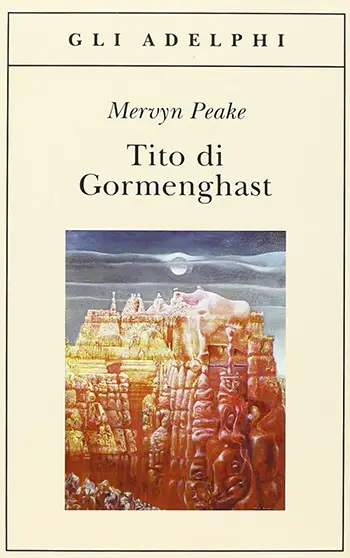
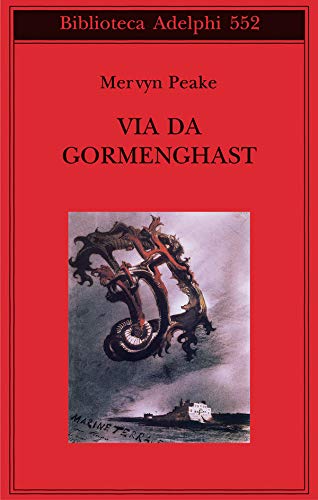
Scrittore di culto le cui opere in Inghilterra sono oggetto di fortunate trasposizioni cinematografiche e hanno ispirato la fervida immaginazione di disegnatori del calibro di Alan Lee, Mervyn Peake ha incontrato nel nostro Paese un’accoglienza piuttosto avara di complimenti da parte della critica specialistica, sebbene a fare gli onori di casa sia stato nientemeno che Roberto Calasso, al quale va il merito di aver incluso nel canone aureo del suo prestigioso catalogo questo autore quantomeno controverso.
I pochi che alle nostre latitudini si sono arrischiati ad esplorare le contorte geometrie di Gormenghast hanno manifestato un certo imbarazzo nel tentativo di incasellare quest’opera oltremodo articolata e complessa entro i parametri dei generi letterari codificati. Tutti sembrano comunque concordi nell’affermare che non si tratta di un romanzo fantasy, laddove con questo termine ampiamente abusato e per la verità impreciso, oggi si è soliti indicare estensivamente la saga di argomento epico. Giudizio questo, a mio modesto parere, senza dubbio affrettato quando non superficiale visto che, ad un’attenta analisi, è facile riscontrare come gli elementi archetipici propri della Quest, come la chiamano gli Inglesi, vale a dire la Cerca di tipo cavalleresco, sono in realtà presenti in maniera inequivocabile.
Dietro i paramenti di una prosa scenografica, polifonica, sovrabbondante di aggettivi fino al parossismo, Mervyn Peake non fa altro che descrivere la caduta di un Regno. Se fosse possibile ridurre la trama alla sua primigenia essenzialità, liberandola da orpelli stilistici e sovrastrutture di sorta, ci troveremmo al cospetto di una rappresentazione teatrale dal sapore elisabettiano, dove un Sovrano legittimo, Sepulcrio, ultimo rappresentante di un’antica stirpe la cui fierezza è ormai un ricordo sfibrato ed esangue ma non per questo meno vincolante per coloro che ne custodiscono le vestigia e ne coltivano la memoria, trova la morte a tradimento per mano di un Antagonista che nelle sue caratteristiche salienti simboleggia la proiezione plastica di un universo valoriale estraneo e anzi direi antitetico al mondo della Tradizione.

Ferraguzzo non è soltanto crudele (il che, di per se, non sarebbe necessariamente un difetto), ma è soprattutto doppiogiochista, intimidatore, arrogante, bugiardo ai limiti del patologico, ha una naturale inclinazione alla doppiezza propria dell’animo votato alla cospirazione: esibisce cioè in sommo grado le qualità del moderno demagogo. Una figura tellurica che opera scientemente in favore del Caos. È, in ultima analisi, una prefigurazione del Kali Yuga. In questa prospettiva la sua uccisione da parte di Tito, erede designato di Gormenghast, assume il significato di un gesto simbolico, un’azione apotropaica tesa a propiziare la ricomposizione della perduta unità del Tutto e, con essa, l’avvento di un ulteriore inizio, una nuova Età dell’Oro, nel rispetto di quella che Mircea Eliade avrebbe chiamato la “sfericità del Tempo” connaturata alle culture premoderne.
Se questi elementi non s’impongono sulle prime all’attenzione del lettore, ciò è dovuto al fatto che, in ossequio ai dettami estetici e stilisti propri del Surrealismo ai quali Mervyn Peake si richiama, i piani narrativi sono disarticolati in favore dell’irruzione di elementi desunti dalla sfera dell’onirico, dai territori inesplorati dell’inconscio. Ecco allora che la Contessa Gertrude ci appare assisa sul suo trono di cuscini ammantata in una veste costituita da centinaia di migliaia di gatti vivi, che si muovono all’unisono in simbiosi con la loro padrona, mentre uccelli di ogni foggia dalle piume variopinte nidificano tra i folti ricci della sua turrita capigliatura…ma questa raffigurazione non la rende meno terribile nel momento in cui con tono ultimativo sentenzia che “non esiste un Altrove, perché tutto conduce a Gormeghast”.

Note:
[1] Karl Jaspers, Genio e Follia. Strindberg e Van Gogh, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001.
[2] Mervyn Peake, Gormenghast, Adelphi, Milano 2005; p. 32.
