di Michele Ruzzai
copertina: Vsevolod Ivanov
Riassunto della conferenza svoltasi in data venerdì 24 febbraio 2017 presso Trieste.
Dopo il precedente incontro su “Le radici antiche degli Indoeuropei” del 27/1/2017 anche questo, svoltosi grazie all’organizzazione di Daniele Kirchmayer, è stato introdotto dalle utili ed interessanti note di Fabio Calabrese, che ha fornito un primo inquadramento dei temi in argomento, insistendo in particolare sul forte conformismo, ideologicamente orientato, dell’attuale ricerca preistorica. In effetti, come punto d’avvio della conferenza, si può senz’altro dire che oggi il mondo accademico, ed anche quello divulgativo rivolto ad un pubblico più vasto, sia fondato su due assunti che tendono a presentarsi come dei veri e propri “dogmi” di fede, in verità tutt’altro che dimostrati: l’evoluzionismo “ascendente” in una prospettiva biologica più generale, e l’afrocentrismo delle origini umane in quella più specificatamente riguardante la nostra specie, Homo Sapiens. Inizieremo esponendo alcuni punti di critica a questi due apriorismi concettuali e successivamente passeremo ad illustrare gli elementi più propriamente costruttivi del discorso.
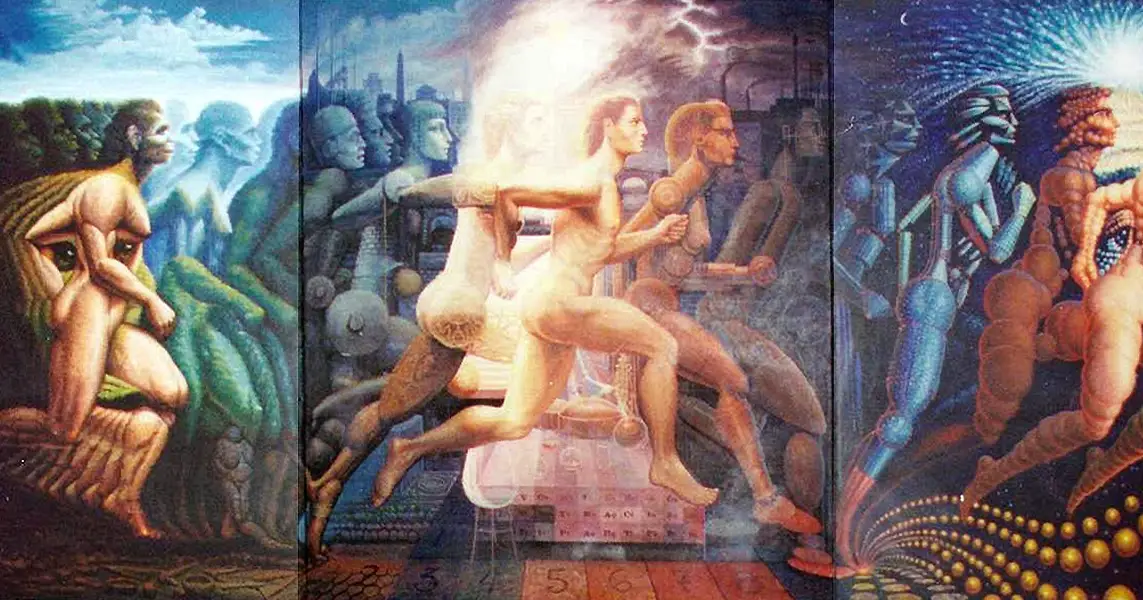
Il primo dogma: l’evoluzionismo ascendente
La teoria evoluzionista, che presuppone un andamento ascendente in termini di complessità delle forme biologiche, può già essere messo in discussione sulla base di una semplice argomentazione logica, portata da autori tradizionalisti come Julius Evola e René Guenon, ovvero l’impossibilità che “il più derivi dal meno”. Com’è possibile, infatti, che la materia inerte si auto-organizzi da sé stessa? Anche in ambito scientifico qualcuno ha posto l’interrogativo se le teorizzazioni evolutivo-ascendenti non siano in contrasto con il secondo principio della termodinamica (o principio di Carnot), noto anche come “legge dell’entropia”, secondo il quale tutti i sistemi abbandonati a sé stessi tendono irrimediabilmente a degradare verso il disordine fino alla distruzione e non certo a migliorarsi secondo un perfezionamento continuo. D’altronde, anche il vero significato etimologico del termine “evoluzione” deriva dal latino “volvere”, cioè srotolare, svolgere, e quindi dovrebbe piuttosto esprimere il concetto di un dispiegarsi delle possibilità di esistenza che esistono in germe già a priori, senza necessariamente implicare un andamento verso l’alto. La stessa “casualità” invocata dagli evoluzionisti, di contro a qualsiasi concezione che implichi l’esistenza di un Logos superiore alla materia, appare come un mero paravento ideologico, una “foglia di fico” che nasconde l’ignoranza dei meccanismi formativi più profondi: i ricercatori evoluzionisti invocano i “tempi lunghissimi” che avrebbero consentito a tale cieca causalità di produrre le forme odierne. Peccato però che i tempi siano ENORMEMENTE lontani da quanto sarebbe stato necessario.
È stato infatti calcolato dal prof. Chandra Wickramasinghe, che la probabilità che l’organismo vivente più semplice nasca “per caso” dalla materia inerte sarebbe di 1 su 10 alla 40.000^ (1 seguito da 40.000 zeri)… Andiamo più nello specifico. Gli stessi evoluzionisti ci dicono che il tempo trascorso dal “brodo primordiale” è pari a UN miliardo di anni, cioè 1 seguito da 9 zeri. Ebbene, il fisico Bogdanov ha calcolato che il tempo necessario perché dai vari nucleotidi si arrivi per puro caso ad una molecola di acido ribonucleico, RNA (che, comunque, NON è un essere vivente, enormemente più complesso) sarebbe stato necessario un numero di anni almeno pari a 10 alla 15^ (1 seguito da 15 zeri, cioè UN MILIONE di miliardi di anni e quindi un tempo UN MILIONE di volte superiore). Il matematico Guye, d’altro canto, ha calcolato che la possibilità che un altro componente fondamentale degli organismi viventi, cioè una proteina (che però anch’essa, di per sé, NON è un essere vivente) si formi per puro caso, è pari ad 1 su 10 alla 161^ potenza (cioè 1 seguito da 161 zeri) ma, tuttavia, avendo teoricamente a disposizione un numero di anni pari a 10 alla 243^ potenza (1 seguito da 243 zeri). Tempi incredibilmente lunghi, INCOMMENSURABILMENTE di più di quanto sarebbe necessario e che rendono semplicemente risibile ogni ricorso “al caso”. A questo punto, credere ad un miracolo, ad una creazione, ad un’emanazione, ad una “discesa” di qualcosa di superiore, o in qualsiasi altro modo lo si voglia definire, appare francamente come l’atteggiamento PIÙ LOGICO. Tra l’altro, non è nemmeno vero che sia mai esistita una semplicità biochimica primitiva, vista l’enorme complessità anche degli organismi monocellulari, e che non si possa nemmeno parlare di una banale ascesa “da piccolo al grande”, se consideriamo i dinosauri estintisi circa 65 milioni di anni fa e sostituiti da specie molto più minute.
Le specie, inoltre, sono portatrici di un’infinità di caratteri del tutti inutili e per nulla spiegabili secondo l’ottica delle mutazioni casuali del genoma e della fissazione di queste attraverso il meccanismo della selezione naturale: colori, forme, profumi, comportamenti senza alcun fine utilitaristico sono abbondantemente presenti in Natura. Selezione naturale che, peraltro, è stato notato essere un meccanismo prettamente conservativo, nel senso che elimina i devianti, e che quindi riveste una funzione eminentemente STABILIZZANTE sulle specie viventi; anche perché mutazioni vantaggiose non sono praticamente quasi mai state osservate, mentre al contrario, ve ne sono spesso di degenerative o, al limite, neutre, senza cioè impatto sulle funzionalità biologiche. Ciò che si contesta, quindi, alle ipotesi evoluzioniste, è la possibilità “trasformista” delle specie di passare progressivamente da una forma all’altra (la cosiddetta “macroevoluzione”), mentre invece non vi sono dubbi su una certa plasticità INTERNA alle singole specie, ovvero la “microevoluzione”: quel fenomeno, ad esempio, ben conosciuto dagli allevatori per selezionare dei nuovi tipi, che però non arrivano MAI a diventare una NUOVA specie. La verità delle evidenze paleontologiche, è che finora sono state scoperte circa 250.000 specie fossili, le quali hanno infatti una stabilità morfologica di lunghissima durata, pari anche a milioni di anni, senza cioè denotare quei lenti cambiamenti progressivi che il darwinismo ascendente necessariamente presupponeva.
Si può dare infine ancora un elemento di riflessione in questa rapidissima carrellata. Gli elementi peculiari che sovrintendono alla forma più macroscopica delle varie specie biologiche, banalmente ciò che al vivente fa assumere le sembianze di un elefante piuttosto che di un airone, come ci ricorda il genetista Giuseppe Sermonti sembrano non trovarsi a livello di DNA: questo, infatti, pare essere più un manuale di istruzioni per la costruzione degli elementi costruttivi di base (ad esempio, le proteine) e per la definizione dei processi biochimici di dettaglio, ma sembra non contenere, a quanto se ne sa oggi, gli elementi informativi sulla struttura generale dell’organismo. Per fare un esempio, è come se il codice genetico rappresentasse una perfezionatissima ed organizzatissima fabbrica di mattoni, ma il cui successivo uso – se per la costruzione di una casa, di un ospedale, di un albergo o di uno stadio – fosse di pertinenza di un ALTRO genere di pianificazione, collocata ad un livello sovrastante.
L’argomento della “forma” tra l’altro ci porta verso l’uomo, con delle considerazioni di particolare interesse. Il nostro aspetto, infatti, pare alquanto generalizzato e poco specializzato, quasi “prototipico” almeno per la classe dei mammiferi, cioè del tutto privo di elementi dal forte significato adattativo-ambientale (pelo, artigli, dentatura, ecc…); elementi che invece sono copiosamente presenti nei vari “cugini” che condividono la famiglia tassonomica degli Ominidi. Ciò avvalorerebbe l’idea che, al contrario di quanto ritenuto “evoluzionisticamente”, l’uomo si sia mosso ben poco da un punto originario di partenza, lasciando invece ad altre specie, più o meno vicine, una dinamica che le ha portate in situazioni più periferiche, in nicchie perfettamente adattate con l’ecosistema circostante. Ma così anche relegandole ad una situazione ormai esaurita, ad un “vicolo cieco” senza ritorno. Paradossalmente è “la scimmia” ad essere più evoluta dell’uomo, il quale è rimasto in un situazione di “centralità” ed “omnipotenzialità”, tanto che è stato ipotizzato che quella Sapiens sia una specie a fortissima tendenza “neotenica” (Louis Bolk), cioè con la persistenza in età adulta di caratteri tipici della primissima infanzia se non addirittura fetali, con tutta la “plasticità” che ciò comporta.
Centralità e costanza nella nostra forma sono dati che, in effetti, mal si accordano con l’idea evoluzionistica secondo la quale il Sapiens sarebbe l’ “ultimo grido” nella serie dei vari Ominidi, gloriosamente in cima ad una scala ascendente, ed in effetti non sono pochi i ritrovamenti che evidenzierebbero per la nostra specie un’antichità enormemente maggiore di quanto attualmente stimato: anche se la paleoantropologia ufficiale evita di parlarne, perché non spiegabili nel suo orizzonte evoluzionista, non mancano reperti che andrebbero in questa direzione, con una profondità temporale anche dell’ordine di qualche milione di anni. Per citarne alcuni: nell’isola di Giava a Trinil; in Argentina a Miramar, a Buenos Aires e sul Monte Hermoso; in California a Calaveras e Table Mountain; in Inghilterra a Foxhall e Ipswich; in Francia a La Denise e Abbeville; in Svizzera a Delemont; in Spagna a Atapuerca; in Italia a Castenedolo e Savona; in Palestina a Qesem; nella stessa Africa, in Kenia vicino al lago Turkana ed in Tanzania, con le famose impronte di Laetoli.
Il secondo dogma: l’afrocentrismo umano
Quelli appena elencati sono reperti decisamente incompatibili con le visuali evoluzioniste ed anche con le teorie afrocentriche (l’ipotesi “Out of Africa”, di seguito per brevità OOA), che ipotizzano una speciazione unica in Africa dell’umanità attuale e la sua successiva diffusione planetaria, soprattutto sulla base di una maggior antichità dei reperti Sapiens ivi rinvenuti (ad esempio, Blombos, Klasies River Mouth, Border Cave…). Ma oltre ai reperti “dimenticati” elencati sopra, la OOA viene messa in crisi anche da altri ritrovamenti che la paleoantropologia ha ben presente (Skuhl, Qafzeh, Qesem in Palestina; Jebel Faya in Arabia, Liujiang in Cina, Kununurru in Australia) e che appaiono difficili da spiegare nell’ottica di una prima migrazione extra-africana anche datata, a voler esser generosi, 80-90.000 anni fa (ma si potrebbe rilevare che una delle più recenti formulazioni dell’OOA – riportata da Spencer Wells – riduce addirittura a 50-60.000 anni fa la prima uscita dal continente, quindi lasciando completamente senza spiegazione TUTTI i siti sopra elencati). Alcuni autori, inoltre (Wolpoff e Thorne), hanno contestato l’OOA anche dal punto di vista archeologico, rilevando la totale assenza di tecnologie litiche (cioè di lavorazione della selce) tipicamente africane al di fuori del continente, che avrebbero dovuto essere portate dai fantomatici “protoafricani” migranti da sud verso nord, est, o nordest. Analogamente, sul piano bio-antropologico altri ricercatori (Richard G. Klein) hanno rilevato come in genere i più antichi ritrovamenti europei ed australiani tendano ad evidenziare delle somiglianze fisiche molto più pronunciate con i loro discendenti di età storica piuttosto che nei confronti di questi presunti antenati africani; ad esempio, nei primi reperti ossei del nostro continente – Combe-Capelle e Cro-Magnon – sono riscontrabili non poche caratteristiche ancora oggi presenti negli attuali europei, o almeno in buona parte di essi.
Di questi “protoafricani” sembra quindi essere alquanto sfuggente una più precisa caratterizzazione razziale. Infatti, alla domanda “quale attuale popolazione africana sarebbe da considerarsi la più diretta discendente di questo ipotetico gruppo iniziale, rimasto in sito, mentre una, o più, sue frazioni sarebbero uscite dal continente?” le possibili risposte non appaiono molto convincenti. Per attenerci ai gruppi principali, possiamo ricordare che attualmente l’Africa è grossomodo popolata da genti caucasoidi nel Maghreb, etiopoidi nella regione del Corno, khoisanidi (Boscimani ed Ottentotti) a sud, ed i “tipici” negridi subsahariani in tutto il resto. I primi sono il probabile risultato di un ingresso da aree euro-occidentali, visto anche il non raro biondismo riscontrato tra diversi Berberi; i secondi sembrano essere geneticamente più vicini alle popolazioni medio-orientali (Cavalli Sforza), stesso discorso che si può fare anche per i khoisanidi, con l’aggiunta che alcuni antropologi a suo tempo ne avevano addirittura ipotizzato una certa vicinanza anche alle popolazioni gialle est-asiatiche. Quindi, la parte degli “autoctoni” africani, inquadrabili come i più diretti discendenti odierni dei “protoafricani” iniziali, rimarrebbe affidata ai negridi sub sahariani: dei quali, quindi, sarebbe lecito aspettarsi ritrovamenti della più elevata antichità. Il problema è che generalmente viene riconosciuto (Kurten, Canella, Biasutti, Bertaux) una carenza abbastanza vistosa di reperti di alta antichità chiaramente negridi, ed i reperti disponibili (forse, ma non inequivocabilmente, Boskop; più probabilmente Asselar) sono relativamente recenti; come di recente formazione viene di conseguenza considerata (Bernatzik, Brian, Coon, Weinert) la genesi dell’intero gruppo negride. C’è quindi uno strano “hiatus” subsahariano, non facilmente spiegabile.
Dunque, quando anche la paleogenetica sostiene di aver “dimostrato” l’origine africana di Homo Sapiens non tiene in considerazione le evidenze fossili e razziologiche o, tra queste, seleziona solo quelle strumentali alla sua visuale preconcetta: in ogni caso evidenziando una dipendenza interpretativa, onestamente ammessa anche dai genetisti Cavalli Sforza e Barbujani, che non le consentono di trarre, in autonomia, le conclusioni finali delle ricostruzioni storico-migratorie. Le evidenze genetiche, cioè, sono perfettamente interpretabili anche in un orizzonte “non afrocentrico”. Ad esempio è stato rilevato (Paul Jordan, Steve Olson) che l’indubbia maggiore eterogeneità interna delle popolazioni africane, invece di indicare una maggiore antichità, e quindi ancestralità, rispetto a tutte le altre del pianeta, potrebbe invece essere il risultato di una distorsione statistica indotta dal fatto che il continente nero è stato probabilmente più popolato di altri, almeno in tempi abbastanza recenti: vi si sarebbe così accumulato un maggior numero di individui con le relative diversificazioni, che quindi avrebbero impiegato più tempo, rispetto ad altre aree del mondo, per scomparire senza lasciare tracce rilevabili.
Anche il fatto che le popolazioni euro-asiatiche appaiano tra loro geneticamente più vicine, può benissimo essere spiegato (Gianfranco Biondi / Olga Rickards), invece che attraverso una loro minor antichità rispetto all’ipotetico ceppo protoafricano originario, piuttosto con un reciproco flusso genico molto più massiccio, ipotesi peraltro abbastanza logica se osserviamo una semplice carta geografica: checché ne dica chi oggi parla di “ponti” e del mare come di un tramite che avvicina genti diverse, sembrerebbe che storicamente il Mar Mediterraneo abbia piuttosto rappresentato una barriera genetica. Senza contare, poi, che gli stessi dati genetici, intesi come “fotografia statica” e scevri da ogni interpretazione di carattere storico, ad esempio nel caso del reperto australiano del Lago Mungo evidenziano una sequenza mitocondriale, cioè di linea femminile, più divergente di qualsiasi altra finora conosciuta comprese quelle africane, quindi chiaramente incompatibile con una provenienza da lì. Inoltre, altri studi rivelerebbero che le popolazioni della Melanesia sarebbero tra le più differenziate del pianeta, presentano molte varianti genetiche altrove ignote e quindi, anche qui, molto poco congruenti con il quadro OOA.
Le varie “sequenze” rilevate sono le evidenze odierne delle varie mutazioni, avvenute casualmente nel genoma umano, e che identificano vari “aplogruppi”, cioè in buona sostanza quegli insiemi di individui portatori degli stessi marcatori genetici e quindi di reciproca parentela più stretta rispetto ad altri; ma tali mutazioni, è bene ricordarlo, sono appunto del tutto casuali ed un elemento essenziale per passare da una rappresentazione “statico-geografica” (le cui evidenze, in sé stesse, sono poco soggette ad interpretazioni) ad una “dinamico-storica” (che invece implicano un elevato livello di congetturalità e cercano di spiegare i passaggi temporali attraverso i quali si è giunti alla situazione attuale) è legato alla stima della velocità alla quale tali mutazioni si sono succedute nel genoma. Un assunto, che però è del tutto indimostrato, di velocità mutazionale grossomodo costante in tutte le popolazioni mondiali, ha portato i genetisti odierni ad ipotizzare una popolazione ancestrale collocata in Africa sulla base della maggior quantità di mutazioni riscontrate ad esempio nei khoisanidi (Boscimani ed Ottentotti) e, di conseguenza, ad interpretare come indice di minor antichità il numero più ridotto riscontrato in altre etnie (ad esempio, noi europei): è fondamentalmente su questa base che a suo tempo è stato formulata l’ipotesi della “Eva africana”, femmina ipoteticamente progenitrice del DNA mitocondriale di tutte le popolazioni mondiali, ad opera di Allan Wilson, poi rivista da Rebecca Cann e Mark Stoneking, le cui conclusioni tuttavia non sarebbero esenti da critiche già nel merito della campionatura scelta a priori (Richard G. Klein). Ma, come detto, l’assunto di una velocità mutazionale costante rimane ancora una mera ipotesi di lavoro (Cavalli Sforza, Christopher B. Stringer) e sembra anzi scontrarsi con evidenze che evidenzierebbero una diversità di ritmo “evolutivo” tra diverse zone del genoma della stessa specie (Veronique Barriel), come anche con le diverse velocità mutazionali riscontrate in funzione della latitudine di stanziamento: significativamente, sembrerebbe che proprio nelle zone tropicali tale rimo si accentui, suggerendo quindi che le popolazioni ivi dislocate siano soggette ad una più sostenuta dinamica di allontanamento rispetto al centro genetico della popolazione.
Di conseguenza, i gruppi meno interessati da tale fenomeno potrebbero essere interpretabili non come più recenti ma piuttosto come quelli rimasti più vicini al comune punto di partenza. Questo ad esempio potrebbe essere il caso proprio di noi europei, che negli alberi filogenetici ricostruiti dai dati molecolari veniamo rappresentati da un ramo particolarmente corto; se non seguiamo l’assunto di una velocità mutazione uguale per tutte le popolazioni mondiali a tale evidenza si può dare il significato, che anche Cavalli Sforza è costretto ad ammettere come ipotesi alternativa, di un gruppo rimasto piuttosto vicino alla forma umana di partenza. Su tali obiezioni interpretative è quindi stato ipotizzato che anche l’Eva mitocondriale non debba, necessariamente, aver fatto parte di una popolazione protoafricana né avere per forza l’età di 200.000 anni che le è stata attribuita (Bryan Sykes, Francesco Fedele). Più recentemente e partendo da altri parametri di ricerca, cioè i polimorfismi del cromosoma Y che si trasmette solo per via paterna, i ricercatori Klyosov e Rozhanski hanno tratto delle conclusioni del tutto contrarie alle ipotesi OOA. I due russi hanno infatti rilevato la totale assenza di aplogruppi “tipicamente africani” da un campione di persone non africane: è vero che non hanno considerato il fatto che la teoria OOA prevede proprio uno sviluppo di queste linee solo in Africa dopo l’uscita dei primi eurasiatici, ma sulla base di tutte le considerazioni precedenti sembra lecito chiedersi se veramente sia stato stabilito con certezza quale dovette essere l’aplogruppo Y-DNA ancestrale rispetto a tutti gli altri.
In ogni caso è comunque sempre Cavalli Sforza a ricordarci come la genetica debba necessariamente appoggiarsi su dati ad essa esterni ed anche come sia possibile una “bidirezionalità” interpretativa dei dati esposti sulle carte “geno-grafiche” (le mappe delle “componenti principali” che ha pubblicato nel suo importante “Storia e geografia dei geni umani”): dati che non affermano necessariamente se i primi uomini fossero africani e si diffusero verso l’Asia o… viceversa (!!!). In definitiva le mappe descrivono una situazione statica ed al massimo evidenziano delle “parentele” più o meno strette tra gruppi diversi, ma non possono mai indicare dinamiche e movimenti migratori: è fondamentale ricordarsi che questi li aggiungiamo sempre noi, sulla base di altri elementi, esterni alla genetica e con il supporto di ulteriori teorie. Ed, in conclusione, bisogna anche ricordare che il modello migratorio ipotizzato dalla OOA (uno o più gruppi usciti dall’Africa, lasciando in sito una larga parte della popolazione rimanente) è fondamentalmente diverso da quella che vedremo, con ogni probabilità partita dal settentrione eurasiatico e le cui tracce sono state quasi del tutto cancellate dagli eventi glaciali del wurmiano. Un settentrione eurasiatico che infatti è ad oggi quasi del tutto disabitato, o ripopolato solo da tempi relativamente recenti, peraltro non da popolazioni ivi originatesi ma adattatesi solo da pochi millenni (è, ad esempio, il caso degli Inuit); ed è quindi chiaro che la distorsione interpretativa di carattere demografico accennata sopra (Paul Jordan, Steve Olson), cioè quella dovuta alla conservazione di alcune linee genetiche altrove andate perdute, non possa applicarsi alle attuali aree artiche.
La visuale ciclica, l’Uomo primordiale, il Polo
Qual è, dunque, il modello più consono nel quale inquadrare la storia umana e che, ad un tempo, superi sia le poco convincenti concezioni evolutivo-ascendenti che quelle afrocentriche? Autori quali Julius Evola e René Guenon hanno dato una risposta a questa domanda, come vedremo appoggiandosi peraltro a Miti e Tradizioni di ogni angolo del pianeta: una fonte imprescindibile per integrare le stesse evidenze scientifiche. Ascoltare ANCHE quanto hanno da dire i “testimoni sul campo”, nella persona dei loro lontani eredi, in merito alle vicende preistoriche e cercare di integrare queste informazioni con le più recenti indagini scientifiche non mi pare un’operazione arbitraria, ma di semplice buon senso.
Lo spunto principale che ci arriva da questa diversa prospettiva è che l’andamento della storia umana non sarebbe lineare-unitario, ma CICLICO: implicherebbe cioè l’esistenza di PIÙ umanità, e la summenzionata eccezionale antichità di molti reperti Sapiens starebbe a dimostrarlo come evidenze di Ere precedenti. Ogni umanità sarebbe compresa in un ciclo definito “Manvantara”, macro-periodo chiuso e separato dagli altri (precedenti e successivi), un concetto che René Guenon ha ripreso dalla Tradizione Indù con una serie di rielaborazioni sulle quali qui non ci soffermeremo. In ogni caso, nell’ottica guenoniana la durata del Manvantara è pari a circa 65.000 anni e tale periodo complessivo è a sua volta suddiviso in 4 Yuga (Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, di durata decrescente in proporzione 4-3-2-1) o anche in 5 Grandi Anni (cioè 5 periodi invece di durata uguale, pari ciascuno a circa 13.000 anni, ovvero la metà di un ciclo precessionale completo); sono due criteri di suddivisione non alternativi ma coesistenti, ed il secondo – in 5 Grandi Anni – a mio avviso potrebbe corrispondere allo schema del greco Esiodo, che parlò di 5 Età: Età dell’Oro, Età dell’Argento, Età del Bronzo, Età degli Eroi, Età del Ferro.
La prima considerazione da fare sulle fonti tradizionali in merito al tema delle origini umane è che nessuna pare confermare l’ipotesi evoluzionista, e nemmeno quella afrocentrica. L’uomo, cioè, non viene mai concepito come un essere derivante da inferiori forme animali, bensì appare piuttosto come qualcosa di “caduto” da superiori stati “super-umani”. Se infatti lo storico delle religioni Mircea Eliade ha opportunamente messo in luce il tema, quasi ecumenico, della “nostalgia delle origini”, cioè quel diffuso sentimento di malinconico ricordo di una superiore condizione esistenziale originaria, possiamo ricordare, a tale proposito, il tema della prima razza esiodea, aurea e che “viveva come Dei”, avvicinabile al tema dell’Androgine platonico, perfetto nella sua completezza, come perfetta ed ancora unitaria era la super-casta originaria Hamsa della Tradizione Indù, prima della sua polarizzazione nelle entità successive. Temi che alludono, dunque, ad una sorta di divinizzazione di quello che dovette essere l’uomo dei primordi, presente ad esempio in Erodoto quando parla degli Iperborei definiti “uomini trasparenti”, o al cinese Li-Tze che cita uomini del nord “trascendenti” e dalle “ossa deboli”. Nello stesso Islam, a nord si colloca quella Hurqaliya, “terra delle anime”, mentre nella Tradizione celtica si cita la “terra dei viventi” abitata da Elfi. Accenni che evidenziano chiaramente anche un ulteriore tema, quello di una “diversa corporeità” dell’uomo primordiale, che peraltro sembrerebbe essere confermata nella quasi totale assenza di reperti scheletrici e litici relazionabili a Homo Sapiens nel lasso 65-52.000 anni fa, ovvero il Primo Grande Anno del presente Manvantara, quello che nella suddivisione quinaria corrisponderebbe, a mio avviso, all’Età dell’Oro di Esiodo.
Un secondo tema che pare emergere, è quello legato alla polarità, con il concetto di Axis Mundi e di una centralità anche spirituale (ad esempio il Monte Meru della Tradizione Indù), peraltro rimarcata sempre da Julius Evola e Renè Guenon, e di una chiara borealità primordiale. Ad esempio, anche nel Vecchio Testamento, precisamente in Isaia 14,13 si legge che la dimora divina sarebbe sul “monte dell’assemblea” il quale si trova “nelle parti più remote del settentrione”; ma comunque terre boreali legate ai tempi delle origini si ritrovano anche nei miti tibetani, con Shambhala, o, ancora nella Tradizione Indù, le terre di Shvetadvipa e, poi, di Shakadvipa, forse interne al più grande continente polare di Ilavrita. L’Iran ricorda la Ayrianem Vaejo, forse più tarda ma pur sempre collocata alle più alte latitudini, mentre nella Tradizione norrena si cita Asgard, residenza dei divini Aesir. Nella tradizione classica sono note le terre di Thule e di Hyperborea, quest’ultima menzionata, in vari contesti, da molti autori (Ecateo di Abdera, Ecateo di Mileto, Erodoto, Esiodo, Pindaro, Omero…) mentre per Thule vi è il celebre viaggio di Pitea di Marsiglia; nel modo latino vi sono analoghi cenni in Virgilio e in Plinio di Vecchio. Addirittura nei contesti mesoamericani si menziona una Tula originaria, visibilmente assonante con la Thule ellenica, come anche nei miti zingari si accenna alla Siberia come paradiso primordiale.
L’Eden artico, la Beringia ed i primi uomini
Senonchè, ci si può chiedere se tali localizzazioni possano esser messe in relazione, oltre che ad un momento autenticamente primordiale e connotato, come detto, da una condizione super-umana e di “diversa corporeità” dell’Essere delle origini, anche ad una fase successiva nella quale l’uomo assume la veste fisiologica odierna e non si identifica più con i “Numi”: quel momento, cioè, nel quale gli Dèi passano ad essere i “fratelli potenti degli uomini”, testimoniando, quindi, che ora il punto di osservazione è passato “al di qua” del limite umano/sovrumano e contraddistingue ormai una forma corporeizzata secondo i canoni odierni, biologicamente Sapiens. L’evento cruciale di tale passaggio, a mio avviso ha lasciato tracce mitiche ben precise: è il “taglio” di Kronos che con la sua falce separa Urano e Gea e conclude una precedente fase ancora aurorale; è la super-casta Hamsa che si polarizza nelle due caste superiori (Brahmana, sacerdoti, e Kshatriya, guerrieri); è il sonno dell’Adamo ancora unitario, dal quale viene estratta la Femmina (come poi vedremo, ulteriormente distinta nella coppia Lilith-Eva); è Pandora che arriva a gettare scompiglio nell’indistinta umanità prometeica. In altri termini, cioè, la Femmina che si manifesta appare come l’elemento della corporeità che emerge, il dato del “sensibile” che si appalesa, ora, a fianco di quello più prettamente “noetico”, maschile.
Quindi una corporeizzazione umana che appare quasi come “precipitazione” di una soluzione satura, che tuttavia si verifica sempre all’interno del Satya Yuga, a mio avviso precisamente in corrispondenza della sua metà, cioè nel passaggio dal Primo al Secondo Grande Anno del Manvantara; ovviamente attraverso tale corporeizzazione, l’uomo adesso viene sottoposto alle condizioni ambientali proprie del nostro piano di esistenza. In conseguenza di ciò, è quindi lecito chiedersi come possano conciliarsi le avverse condizioni climatiche dell’Artico con l’esistenza umana, peraltro ricordata nei miti secondo i canoni di uno stato “edenico” dalle caratteristiche gradevoli. La risposta è che, evidentemente, alcune decine di migliaia di anni fa le aree boreali furono interessate da condizioni ben diverse da quelle attuali. Intanto si può ricordare che il Mar Glaciale Artico al tempo dovette presentare una situazione idrografica più chiusa per la presenza di vaste aree emerse, conseguenza della glaciazione che imprigionava milioni di chilometri cubi di acqua con il conseguente abbassamento del livello marino, su scala globale, di almeno 120 metri; aree emerse che a oriente impedivano del tutto il collegamento con l’Oceano Pacifico (lo stretto di Bering era chiuso) e ad occidente limitavano di molto il collegamento con l’Oceano Atlantico (vaste aree emerse tra le isole Britanniche e l’Islanda/Groenlandia). Di conseguenza il bacino artico presentava una temperatura superiore a quella odierna (studi di Saks, Belov, Lapina) e sicuramente non era ghiacciato, perché altrimenti non avrebbe potuto fornire, attraverso l’evaporazione acquea, quelle enormi masse di umidità che, raffreddandosi in quota, dovettero necessariamente rifornire la calotta wurmiana attraverso le continue, abbondanti, nevicate.
Ma, oltre al mare, anche la terraferma offre diversi elementi testimonianti una clima quasi temperato attraverso ritrovamenti vegetali, animali, o evidenze stratigrafiche evidenzianti sorprendenti assenze di glaciazione: dall’Isola di Baffin, alla Groenlandia settentrionale, la Norvegia e la Finlandia settentrionale, il bacino del Pechora e la costa russa sul mar di Barents, i ritrovamenti di Vladimir Pitulko alla foce dello Jenissej (databili 45.000 anni fa), il delta de fiume Yana nella Siberia orientale, per arrivare alla vasta terra di Beringia, probabilmente lussureggiante ed emersa per centinaia di migliaia di chilometri quadrati. E proprio in merito a questa, va notato come recentemente con il nome “Out of Beringia” (Spencer Wells) è stato denominato un modello scientifico secondo il quale si ipotizza che popolazioni rimaste stanziali in zona per un lasso non trascurabile di tempo, abbiano ivi subito un processo piuttosto marcato di diversificazione genetica, per partire solo in un secondo momento, ed a scansioni diverse, verso mete più meridionali, sia in direzione sudorientale che sudoccidentale. È evidente come, dal nostro punto di vista “boreale”, tale ipotesi sia estremamente interessante: anche se la teoria “Out of Beringia” non viene posta in reale alternativa alla “Out of Africa”, ma ne sottolinei al massimo una funzione di “centro di smistamento”, che fu importante ma pur sempre secondario, a mio avviso ciò non toglie che ci troviamo davanti ad un’ipotesi comunque non trascurabile di “culla” umana posta a latitudini significativamente elevate, che non risulta prima fossero mai state teorizzate dalla moderna ricerca scientifica. Per inciso, poco più ad est, in America, si trova il sito di Old Crow nello Yukon settentrionale, forse databile 50.000 anni fa (Fiorenzo Facchini) che peraltro sembrerebbe tra i più antichi siti americani, diversi dei quali (Topper, Taber, Monte Verde…) presentano datazioni così elevate, almeno 40.000 anni, da mettere in seria discussione un ulteriore “dogma” della paleoantropologia attuale, ovvero il “Clovis first” (ovvero l’assunto che la cultura Clovis, di soli 13-14.000 anni fa, rappresenti la prima traccia di presenza umana nel continente americano).
Si tratta quindi di terre che potenzialmente erano adatte a sostenere la presenza umana, ed in particolare l’area tra Siberia orientale ed Alaska occidentale sembra particolarmente interessante non solo per il modello “Out of Beringia”, ma anche per un collegamento di carattere mitico con quanto riportato nella Tradizione Indù a proposito della terra di Varahi, corrispondente al terzo Avatara di Vishnu, il Cinghiale (probabilmente “disceso” 52.000 anni fa), in rapporto al quale dovette verificarsi una sorta di “passaggio” sacrale dalla regione più prettamente polare a quella nordorientale. L’antica Beringia potrebbe dunque essere stata quell’Eden primordiale che, nel corso del Secondo Grande Anno del Manvantara, ospitò la prima umanità corporeizzata “post-androginica” e forse un’ulteriore conferma di ciò può sussistere nell’identica radice “Vara” che nella vicina lingua iranica significa quel “recinto” che avrebbe circoscritto il “Pairi-daeza” (rif. interessanti note di Giuseppe Acerbi), cioè il “Paradiso terrestre” del mito biblico. Quindi condizioni paradisiache anche per un’umanità ormai corporeizzata (ricordiamoci che comunque ci troviamo ancora nel Satya Yuga) e che trovano riscontro anche in analoghi passi della Tradizione classica: in Ovidio e Virgilio, si ricorda infatti quell’antica “eterna primavera” che testimonierebbe anche di un’altra particolarità climatico-astronomica, ovvero l’assenza delle stagioni conseguente alla perpendicolarità dell’asse terrestre rispetto al piano dell’eclittica, sottolineata anche da René Guenon e Julius Evola per i tempi primordiali.
Il dato dell’ “eterna primavera” può, inoltre, portare a delle considerazioni di carattere antropologico, chiedendoci quale tipo umano può essersi sviluppato in quelle particolari condizioni. Pur trovandoci alle alte latitudini, la relativa mitezza climatica non sembra coerente con lo sviluppo di un tipo dalle caratteristiche nordiche secondo i canoni attuali, che sembrano essersi stabilizzate in contesti più freddi. Dato il livello comunque non eccessivo di irradiazione solare, sembra d’altro canto fuori discussione lo sviluppo di tipi melanodermi, mentre quello di popolazioni simili agli attuali est-asiatici non pare corroborato da ritrovamenti scheletrici particolarmente antichi. In definitiva, mongolidi, negridi e nordici “classici” sono tipi altamente specializzati ed, in varia misura, piuttosto recenti, che non sembrano adatti a rivestire i panni della prima umanità.
Rimarrebbe un ultimo gruppo, tradizionalmente noto come Razza Rossa, ed infatti sembra anche particolarmente significativo che Evola, quando porta esempi fotografici di quei “resti della razza prenordica” (la razza primordiale di origine artica, a rigore solo un po’ meno antica del nucleo veramente unitario ed ecumenico di partenza) proponga individui per nulla biondi o dalla pigmentazione eccezionalmente chiara, oltretutto rinvenendoli in gran parte tra i Nativi nord-americani. In termini un po’ meno stretti, si può forse dire che la stirpe di partenza può aver avuto delle caratteristiche “paleoeuropoidi” o “caucasoidi arcaiche” (visto che, come detto, quelle più specificatamente europidi, negridi e mongolidi si sono sviluppate più tardi), dal momento che questo tipo, più “generico” sembra attestato un po’ ovunque sul pianeta come substrato antecedente ad ogni stratificazione/specializzazione successiva (Biasutti, Giuffrida-Ruggeri, Grottanelli, Olson). Per fare un altro esempio, si tratterebbe di una forma non lontana dagli attuali Ainu giapponesi e, forse, ai Combe Capelle preistorici, definiti anche “protomediterranei”, che infatti sembrano antecedenti agli stessi Cro-Magnon.
Le prime migrazioni da Nord
Nel mondo i primi reperti Sapiens attribuibili a questo Manvantara inziano ad apparire circa 50.000 anni fa, e quindi testimonierebbero una primissima migrazione “Out of Beringia” poco dopo l’antropogenesi corporeizzata di 52.000 anni fa. Si può quindi pensare ad una quasi immediata dicotomizzazione del ceppo umano primordiale, ad una prima divisione tra coloro che uscirono precocemente dall’Eden nordico e coloro che vi rimasero; e siccome, come sopra accennato, il tema della corporeità viene spesso accostato al concetto della Femmina, non si può escludere che un lontano richiamo di questa prima separazione possa risiedere nella “duplicità” che spesso viene accostato alla donna. Nel Mito iranico, ad esempio, l’uomo primordiale Gayomart ha due spose, una bianca ed una nera, come anche nel contesto semitico si ricorda che Adamo, prima di Eva, ebbe in consorte l’oscura Lilith.
E proprio Lilith, con la sua repentina fuga dal Paradiso Terrestre ed in relazione ad alcuni elementi che la collegherebbero all’australità (Jacques Bril, Giuseppe Sermonti), potrebbe rappresentare quella prima ondata di genti che si diressero “verticalmente” a sud, verso le zone tropicali, in tempi così antichi ed instaurando un tipo di civiltà di segno soprattutto ctonio/lunare da smarrire quasi completamente ogni riferimento all’originaria borealità, ma non fino al punto di non conservarne qualche flebile traccia: ad esempio i ricordi polari dei pigmoidi Semang malesi, o i lontani elementi culturali che l’etnologo Leo Frobenius ritenne di scorgere tra i Boscimani sudafricani. Anche nel libro “Il Selvaggio. Saggio sulle degenerazione umana” Silvano Lorenzoni inquadra le popolazioni pigmoidi come le “prime cadute” giunte dalle aree nordiche, nucleo probabilmente iniziale dei molto più tardi negridi (come anche ritenuto dall’antropologo Carleton Coon). Un’uscita precoce e geograficamente finita molto lontano dalla sede primaria che avrebbe condotto tali gruppi ad esporsi, analogamente, ai primi fenomeni di “deriva genetica” e di allontanamento rapido dal tronco umano più centrale, evidenziando ancora oggi quell’elevato numero di mutazioni che, erroneamente, viene interpretato come indice di maggiore antichità invece che di maggiore perifericità. Invece, la rimanente parte dell’umanità rimasta a nord, in termini antropologici potrebbe corrispondere a quella razza “paleoartica” ipotizzata da Wiklund, dalla quale più tardi si sarebbero differenziati sia gli europidi che i mongolidi e, in termini genetici, forse coincidere, o rappresentare l’ambito entro il quale si sarebbe poi specificato, quell’arcaico gruppo “nordeurasiatico” che alcune ricerche recenti avrebbero individuato alla radice di TUTTI gli attuali europei.
Ma dopo qualche millennio, anche quest’insieme si sarebbe a sua volta diviso, in primis ad opera delle popolazioni accostabili ad Eva, che, proprio come una “costola” si sarebbe separata più o meno lateralmente da un nucleo “adamico” ancora più interno, andando però ad occupare sedi decisamente meno australi dei “lilithiani” precedenti: probabilmente favoriti nelle loro migrazioni da un periodo climaticamente meno rigido, forse corrispondente all’interstadio Laufen/Gottweig, tali gruppi si sarebbero dispiegati soprattutto lungo una direttrice est-ovest lasciando forse una traccia della loro antica unità in quella che oggi appare come la frammentata superfamiglia linguistica “sinodenecaucasica” composta dal Basco, alcune parlate caucasiche, il Burushaski pakistano, il Ket dello Jenissei, il Sinotibetano ed il Na-dene nordamericano. Non si potrebbe escludere che il ramo più occidentale di questo raggruppamento abbia avuto una qualche relazione con i “prenordici” ipotizzati da Hermann Wirth, probabilmente attestati in aree subartico-nordatlantiche, terre che al tempo dovettero essere emerse soprattutto in prossimità della linea Irlanda-Islanda, dove ora giace sommerso il banco di Rockall.
Inoltre, un’interessante tradizione di ambito cristiano riferisce che Eva era uscita dall’Eden e qui venne tentata dal Serpente che la convinse a peccare: forse un’immagine figurata per simboleggiare l’inizio di una serie di contatti degli “evaici” con le genti “lilithiane”, carattere etnico e spirituale, che non escluderei potrebbe essere testimoniata dalla progressiva “ondata di ritorno” verso nord di segni e simboli che Evola riconduce alla “Luce del Sud”. Significativa appare, ad esempio, una delle prime statuette del Paleolitico Superiore, quella dell’uomo-leone di Hohlenstein, nel sud della Germania e che potrebbe avere 40.000 anni: evidenza di una penetrazione verso nord di riferimenti mitici più meridionali ed, oltretutto, in significativa assonanza con quello che fu il quarto avatara di Vishnu, Narasimha, l’uomo-leone, ovvero l’ultimo del Satya Yuga (e ricordiamo che quello successivo, il primo del Treta Yuga, fu Vamana, il nano: visibilmente accostabile alle popolazioni pigmoidi che avrebbero preso il sopravvento di lì a poco).
Conflitto, Caduta e abbandono del Nord
Dunque verso il finire dell’Età Paradisiaca nei settori atlantici dovettero verificarsi importanti ed articolati fenomeni meticciatori tra stirpi più o meno direttamente derivate dall’originario tronco boreale: furono le “figlie degli uomini” che si unirono ai “figli di Dio”, generando infine quei Giganti occidentali che potrebbero corrispondere ai Cro-Magnon, sensibilmente più alti dei precedenti Combe Capelle (Homo Aurignacensis) e che anche secondo Herman Wirth sarebbero il risultato dell’unione di varie stirpi, più o meno nordiche. Il raggiungimento del senso di una specificità etnica e spirituale nei confronti dei ceppi “adamici” più boreali ed originari avrebbe condotto queste popolazioni a muovere, nei loro confronti, un conflitto che il Mito ricorda con il tema del colpo sferrato da Atalanta nei confronti del Cinghiale, simbolo sacerdotale, ricordato anche da Renè Guenon. Sempre in ambito ellenico, la discordia tra gli “adamici” nordorientali e gli “evaici” occidentali viene probabilmente ricordata anche nelle vicende della Titanomachia, evento bellico che sancisce infine la vittoria di Zeus ma anche la fine di un’Era e l’avvento delle stagioni.
Gli effetti macrocosmici di tali eventi spirituali, e la loro reciproca solidarietà, implicò dunque come causa/effetto finale l’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano dell’eclittica, la “Caduta” del polo celeste e, con esso, l’abbandono definitivo delle aree iperboreo-orientali alla fine del Secondo Grande Anno del Manvantara. Il nucleo “adamico” fino ad allora rimasto relativamente compatto, iniziò anch’esso a disperdersi, mantenendo tuttavia una certa memoria dell’unità originaria attraverso la comune appartenenza delle varie famiglie linguistiche da esso derivante in una macro-entità che è stata definita in vari modi, soprattutto “nostratico”, ma a mio parere meglio espressa da alcuni ricercatori quali Dolgopolskij (“Boreale”), Andreev (“Paleoboreale”) e Greenberg (“Eurasiatico”). In ogni caso, subito dopo la “Caduta” e la perdita dell’Eden nordico, giunse una fase di particolare influenza dei “Giganti” Cro-Magnon, che forse corrisposero alla “razza di bronzo” di Esiodo, che in effetti fu la terza della sua serie quinaria, com’è anche vero che ora ci troviamo nel Terzo Grande Anno del Manvantara.
La notevole energia e vitalità di questo tipo può forse trovare conferma anche nelle tracce genetiche osservabili dalla “seconda componente principale” rilevata da Cavalli Sforza, che infatti denota due poli opposti, uno nella Scandinavia settentrionale e l’altro nella zona pirenaica: quest’ultimo, però, non arriva a sommergere del tutto l’antico debito con le stirpi più direttamente riconducibili al ceppo nordico originario, dal momento che mentre le tracce genetiche degli antichi “nordeurasiatici” sembrerebbero riscontrabili, come detto sopra, in TUTTI gli attuali europei, quelle del nucleo più cromagnoide-occidentale (che in piccola misura possono aver ricevuto, nei processi meticciatori descritti, anche una certa quota di geni “lilithiani” dall’Africa) pare non abbia influenzato la parte nordorientale del nostro continente. Tuttavia i Cro-Magnon costituirebbero la forma dalla quale si sarebbero poi originati diversi tipi europei, tra i quali i paleo-atlantidi (bruni) e, in una variante depigmentata, quei “dalici” che Evola ricorda anche come “razza bionda pesante”, probabilmente sviluppatasi sotto la pressione dei rigori glaciali in tempi ormai lontani dall’ “eterna primavera” di 20.000 anni prima. Tale ceppo, forse corrispondente alla “razza eroica” di Esiodo (la quarta, nel suo schema quinario), avrebbe poi ricevuto numerosi innesti dall’antica linea “combecapelloide” più leggera per infine giungere alla formazione della razza nordica “classica”, dalla corporatura “leptomorfa” cioè più snella e slanciata: sarebbe stato in quest’ambito “nordico-eroico” che si sarebbe infine enucleata, nel corso del Quarto Grande Anno – quindi in tempi già distanti dall’Eden nordorientale ma tuttavia ancora paleolitici – la famiglia etnolinguistica indoeuropea nella sua “Urheimat” in prossimità del Mar di Barents, i cui dettagli sono stati esposti nel precedente incontro su “Le radici antiche degli Indoeuropei”.
BIBLIOGRAFIA CONSULTATA
Nota: per ovvie ragioni di praticità, nella conferenza “Patria Artica o Madre Africa?” del 24/2/2017 si è dovuto necessariamente sorvolare su diversi aspetti legati ai temi delle origini. Tuttavia, pur senza minimamente pretendere di essere esaustiva, nella stesura della presente bibliografia si è preferito offrire ai lettori un ventaglio il più ampio possibile di riferimenti utili: è stato quindi inserito anche qualche testo non direttamente richiamato nell’esposizione dell’articolo, ma le cui tematiche sono comunque strettamente connesse al filo generale del discorso anche se non si è potuto svilupparle adeguatamente. Le edizioni indicate sono quelle effettivamente consultate, ma molti libri ormai sono stati successivamente ristampati.
- AA.VV. – La Tradizione artica – Numero speciale doppio 27-28 di Arthos – 1983/1984
- AA.VV. (a cura di Antoine Faivre e Frederick Tristan) – Androgino – ECIG – 1986
- AA.VV. (a cura di Onorato Bucci) – Antichi popoli europei. Dall’unità alla diversificazione – Editrice Universitaria di Roma-La Goliardica – 1993
- AA.VV. (a cura di Marco Iacona) – Il maestro della Tradizione. Dialoghi su Julius Evola – Controcorrente – 2008
- AA.VV. (a cura di Ugo Bianchi) – La “doppia creazione” dell’uomo negli Alessandrini, nei Cappadoci e nella gnosi – Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri – 1978
- AA.VV. (a cura di Jean Guilaine) – La preistoria da un continente all’altro – Gremese Editore – 1995
- Giuseppe Acerbi – Apam Napat, il valore delle Acque nella letteratura vedica e nella cultura hindu; http://allependicidelmontemeru.blogspot.it/2014/06/apam-napat-il-valore-delle-acque-nella.html
- Giuseppe Acerbi – Il culto del Narvalo, della balena e di altri animali marini nello sciamanesimo artico – in: Avallon, n. 49, “Il tamburo e l’estasi. Sciamanesimo d’oriente e d’occidente”, 2001
- Giuseppe Acerbi – Il Sumeru, la Montagna Polare nella cosmografia hindu – in: Algiza, n. 7 – Aprile 1997
- Giuseppe Acerbi – Introduzione al Ciclo Avatarico, parte 1 – in: Heliodromos, n. 16 – Primavera 2000
- Giuseppe Acerbi – Introduzione al Ciclo Avatarico, parte 2 – in: Heliodromos, n. 17 – Primavera 2002
- Giuseppe Acerbi – L’Isola Bianca e l’Isola Verde – Sito Associazione Culturale Simmetria; http://www.simmetria.org/images/simmetria3/pdf/Rivista_41_2016_A5_booklet.pdf
- Giuseppe Acerbi – La simbologia fitomorfica: l’orticoltura nel mito delle origini – in: Vie della Tradizione, n. 90 – Aprile/Giugno 1993
- Giuseppe Acerbi – Uttara kuru, il paradiso boreale nella cosmografia e nell’arte indiana; http://allependicidelmontemeru.blogspot.it/2013/06/uttara-kuru-il-paradiso-boreale-nella.html
- Francesco Agnoli / Alessandro Pertosa – Contro Darwin e i suoi seguaci – Fede e Cultura – 2006
- Ezio Albrile – Erotica Gnostica – in: Vie della Tradizione, n. 140 – Ottobre/Dicembre 2005
- Ezio Albrile – La caduta nel Kenoma – in: Vie della Tradizione, n. 119 – Luglio / Settembre 2000
- Ezio Albrile – Siamo tutti figli di Adamo ? (seconda parte) – in: Vie della Tradizione, n. 99, luglio-settembre 1995
- Maurizio Alessandri – L’animale simile a Dio – Luna Editore – 2000
- Samuel Amsler – Il segreto delle nostre origini. La singolare attualità di Genesi 1-11 – Claudiana – 1999
- Fabrizio Ardito / Daniela Minerva – La ricerca di Eva – Giunti – 1995
- Piero Ardizzone – Gli avatara di Visnu. Esoterismo a confronto – Jupiter – 1995
- Basilio M. Arthadeva – Scienza e verità – Edizioni Logos – 1987
- Arvo – L’origine delle specie secondo l’esoterismo – Introduzione alla Magia – Vol. 3 – Edizioni Mediterranee – 1990
- Arvo – Sulla tradizione iperborea – Introduzione alla magia – Vol. 2 – Edizioni Mediterranee – 1987
- Guido Barbujani – L’invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana – Bompiani – 2006
- Mario Bacchiega – Lineamenti di storia delle religioni – Bastogi – 1999
- Marie Balmary – Abele o la traversata dell’Eden – EDB – 2004
- Flavio Barbiero – Una civiltà sotto ghiaccio – Editrice Nord – 1974
- Veronique Barriel – L’origine genetica dell’uomo moderno – in: Le Scienze – Aprile 2000
- Baumer Franz – La Grande Madre: scenari da un mondo mitico – ECIG – 1995
- Hugo A. Bernatzik – Popoli e Razze – Editrice Le Maschere – 1965
- Pierre Bertaux – Africa. Dalla Preistoria agli stati attuali – in: Storia Universale Feltrinelli – Feltrinelli – 1968
- Enzo Bianchi – Adamo, dove sei ? Commento esegetico-spirituale ai capitoli 1-11 del libro della Genesi – Edizioni Qiqajon – 1994
- Ugo Bianchi – Prometeo, Orfeo, Adamo. Tematiche religiose sul destino, il male, la salvezza – Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri – 1976
- Ugo Bianchi – Razza aurea, mito delle cinque razze ed Elisio – Studi e materiali di storia delle religioni, Vol. XXIV – anno 1963
- Renato Biasutti – Razze e Popoli della terra – UTET – 1959
- Gianfranco Biondi / Olga Rickards – Uomini per caso. Miti, fossili e molecole nella nostra storia evolutiva – Editori Riuniti – 2004
- John Blanchard – Evoluzione, mito o realtà ? – Passaggio – 2004
- Maurizio Blondet – L’Uccellosauro ed altri animali (la catastrofe del darwinismo) – Effedieffe – 2002
- Franz Boas – L’uomo primitivo – Laterza – 1995
- Giulia Bogliolo Bruna – Paese degli Iperborei, Ultima Thule, Paradiso Terrestre – in: Columbeis VI – Università di Genova, Facoltà di Lettere, Dipartimento di Archeologia Filologia Classica e loro tradizioni – 1997
- Antonio Bonifacio – I Dogon: maschere e anime verso le stelle – Venexia – 2005
- Antonio Bonifacio – L’Egitto dono di Atlantide – Edizioni Agpha Press – 1998
- Antonio Bonifacio – La caverna cosmica. La potenza dello shamanismo nell’arte rupestre paleolitica – Simmetria edizioni – 2005
- Roberto Bosi – I Lapponi – Il Saggiatore – 1969
- Arthur Branwen – Ultima Thule. Julius Evola e Herman Wirth – Edizioni all’insegna del Veltro – 2007
- Michel Brezillon – Dizionario di Preistoria – Società Editrice Internazionale – 1973
- Luigi Brian – Il differenziamento e la sistematica umana in funzione del tempo – Marzorati Editore – 1972
- Jacques Bril – Lilith o l’aspetto inquietante del femminile – ECIG – 1990
- Alberto Broglio – Introduzione al Paleolitico – Editori Laterza – 1998
- Alberto Broglio, Janusz Kozlowski – Il Paleolitico. Uomo, ambiente e culture – Jaca Book – 1987
- Titus Burckhardt – L’Uomo universale – Edizioni Mediterranee – 1981
- Titus Burckhardt – Scienza moderna e saggezza tradizionale – Borla – 1968
- Giulio Busi (a cura) – Zohar. Il libro dello splendore – Einaudi – 2008
- Mario F. Canella – Razze umane estinte e viventi – Sansoni – 1940
- Giuseppe Cardile – Preistoria (Leggende e Scienza) – Edizioni Nirvana – 1932
- Jules Carles – Il primo uomo – San Paolo – 1995
- Angelo Casanova – La famiglia di Pandora. Analisi filologica dei miti di Pandora e Prometeo nella tradizione esiodea – CLUSF-Cooperativa Editrice Universitaria – 1979
- Carla Castellacci – Il piacere di raccontare – in: Sapere – Ottobre 2004
- Luigi Luca Cavalli Sforza – Chi siamo. La storia della diversità umana – Mondadori – 1993
- Luigi Luca Cavalli Sforza – Geni, popoli e lingue – Adelphi – 1996
- Luigi Luca Cavalli Sforza – Il caso e la necessità. Ragioni e limiti della diversità genetica – Di Renzo Editore – 2007
- Luigi Luca Cavalli Sforza – Storia e geografia dei geni umani – Adelphi – 1997
- Massimo Centini – Sogno e sciamani – in: Avallon, n. 43 “La sapienza velata. Sogno, visione, oracoli” – 3/1997
- Georges Charachidzé – Prometeo o il Caucaso – Feltrinelli – 1988
- Louis Charpentier – Il mistero Basco. Alle origini della civiltà occidentale – Edizioni L’Età dell’Acquario – 2007
- Bruno Chiesa – Creazione e caduta dell’uomo nell’esegesi giudeo-araba medievale – Paideia Editrice – 1989
- Mario Cimosa – Genesi 1-11. Alle origini dell’uomo – Editrice Queriniana – 1984
- Grahame Clark – La Preistoria del mondo – Garzanti – 1986
- Daniela Cocchi Genik – Manuale di Preistoria. Paleolitico e Mesolitico – Comune di Viareggio, Assessorato alla Cultura / Museo Preistorico ed Archeologico “Alberto Carlo Blanc” – 1993
- Chris Collins – La rapida diffusione dell’uomo moderno in Europa – Sito Le Scienze – 2/11/2011; http://www.lescienze.it/news/2011/11/02/news/fu_molto_rapida_la_diffusione_delluomo_moderno_in_europa-632107/
- Maria Teresa Colonna – Lilith, la luna nera e l’eros rifiutato – Edizioni del Riccio – 1980
- Ananda Kentish Coomaraswamy – La dottrina del sacrificio – Luni Editrice – 2004
- Ananda Kentish Coomaraswamy – L’albero, la ruota, il loto – Editori Laterza – 2009
- Carleton S. Coon – L’origine delle razze – Bompiani – 1970
- Henry Corbin – Corpo spirituale e Terra celeste – Adelphi – 1986
- Michael Cremo – Le origini segrete della razza umana – OM Edizioni – 2008
- Michael Cremo / Richard Thompson – Archeologia proibita: la storia segreta della razza umana – Gruppo Editoriale Futura – 1997
- Nuccio D’Anna – A proposito del rapporto Julius Evola–Hermann Wirth – in: Vie della Tradizione n. 140 – ottobre/dicembre 2005
- Nuccio D’Anna – I cicli cosmici nell’Ellade arcaica – in: I quaderni di Avallon, n. 34 – 1995
- Nuccio D’Anna – I custodi del Graal – in: Arthos, n. 14 (nuova serie) – Anno 2006
- Nuccio D’Anna – Il Dio Giano – SeaR Edizioni – 1992
- Nuccio D’Anna – Il gioco cosmico – Rusconi – 1999
- Nuccio D’Anna – Julius Evola e l’Oriente – Edizioni Settimo Sigillo – 2006
- Nuccio D’Anna – Parashu-Rama e Perseo – in: Arthos, n. 33-34 – 1989/1990
- Nuccio D’Anna – Renè Guenon e le forme della Tradizione – Il Cerchio – 1989
- Nuccio D’Anna – Un aspetto del simbolismo della croce: lo “swastika” – in: Arthos, n. 15 (nuova serie) – 2007
- Bruno d’Ausser Berrau – La Scandinavia e l’Africa – Centro Studi La Runa – 1999
- Marie-Madeleine Davy – Nozze mistiche. Sulla metafisica degli opposti – ECIG – 1993
- Luigi De Anna – Il mito del Nord. Tradizioni classiche e medievali – Liguori Editore – 1994
- Luigi De Anna – Thule. Le fonti e le tradizioni – Il Cerchio – 1998
- Jean De Fraine – La Bibbia e l’origine dell’uomo – Nuova Accademia Editrice – 1965
- Giorgio de Santillana / Hertha von Dechend – Il Mulino di Amleto. Saggio sul mito e sulla struttura del tempo – Adelphi – 2000
- Gianfranco de Turris – Trasformazioni del mito edenico – saggio introduttivo a “Arturo Graf – Il mito del paradiso terrestre – Edizioni del Graal – 1982”
- Bernardino del Boca – La dimensione della conoscenza – Edizioni L’Età dell’Acquario – senza indicazione di data
- Mario Del Gatto – La Creazione, l’Uomo, la Caduta – Atanor – 1990
- Christine Dell’Amore – Sapiens d’Arabia – sito National Geographic – 28/01/2011; http://www.nationalgeographic.it/scienza/2011/01/28/news/uomo_via_dall_africa_era_glaciale-175550/
- Deswell / Helveroi / Siegert / Svendsen – La lezione dell’Artico – in: Le Scienze – Dicembre 2002
- Giacomo Devoto – Il concetto di “Lega Linguistica” – in: “AA.VV. – Atti del III Convegno internazionale di Linguisti tenuto a Milano nei giorni 6-10 settembre 1958 – Sodalizio Glottologico Milanese – Università di Milano – 1961”
- Alexandre Dorozynski / Thierry Pilorge – Dall’Eden al mondo – Scienza e Vita – Maggio 1996
- Gianfranco Drioli – Iperborea. Ricerca senza fine della Patria perduta – Ritter – 2014
- Aleksandr Dughin – Continente Russia – Edizioni all’insegna del Veltro – 1991
- Aleksandr Dughin – Siberia – in: “La Nazione Eurasia”, n. 5 – Giugno 2004; http://lanazioneeurasia.altervista.org/archivio2004.htm
- Edith Ebers – La grande era glaciale – Sansoni – 1957
- Mircea Eliade – Il mito dell’eterno ritorno – Borla – 1999
- Mircea Eliade – Il mito della reintegrazione – Jaca Book – 2002
- Mircea Eliade – Immagini e simboli – TEA – 1997
- Mircea Eliade – La nostalgia delle origini – Morcelliana – 2000
- Mircea Eliade – Lo Sciamanismo e le tecniche dell’estasi – Edizioni Mediterranee – 1995
- Mircea Eliade – Mefistofele e l’Androgine – Edizioni Mediterranee – 1995
- Mircea Eliade – Miti, sogni e misteri – Rusconi – 1990
- Mircea Eliade – Mito e realtà – Borla – 1993
- Mircea Eliade – Storia delle credenze e delle idee religiose. Vol. 1: Dall’età della pietra ai Misteri Eleusini – Sansoni – 1999
- Mircea Eliade – Trattato di storia delle religioni – Bollati Boringhieri – 1999
- Julius Evola – I saggi della Nuova Antologia – Ar – 1982
- Julius Evola – Il mistero del Graal – Edizioni Mediterranee – 1997
- Julius Evola – Il “mistero Iperboreo”. Scritti sugli Indoeuropei 1934-1970 – a cura di Alberto Lombardo, Quaderni di testi evoliani n. 37 – Fondazione Julius Evola – 2002
- Julius Evola – Il mito del sangue – Edizioni di Ar – 1978
- Julius Evola – La Tradizione ermetica – Edizioni Mediterranee – 1996
- Julius Evola – Metafisica del Sesso – Edizioni Mediterranee – 1996
- Julius Evola – Rivolta contro il mondo moderno – Edizioni Mediterranee – 1988
- Julius Evola – Simboli della Tradizione Occidentale – Arktos Oggero Editore – 1988
- Julius Evola – Sintesi di dottrina della razza – Edizioni di Ar – 1978
- Fiorenzo Facchini – Il cammino dell’evoluzione umana. Le scoperte e i dibattiti della paleoantropologia – Jaca Book – 1994
- Angelica Fago – Mito esiodeo delle razze e logos platonico della psichè: una comparazione storico-religiosa – Studi e materiali di storia delle religioni, Vol. 57 – anno 1991
- Antoine Faivre – Esoterismo e Tradizione – ELLEDICI – 1999
- Francesco Fedele – Idee vecchie e nuove sulle nostre origini vicine – in: Le Scienze, Quaderni, n. 73 “L’evoluzione dell’uomo” – Settembre 1993
- Giancarlo Finazzo – La realtà di mondo nella visione cosmogonica esiodea – Edizioni dell’ateneo – 1971
- Rand e Rose Flem-Ath – La fine di Atlantide – Piemme – 1997
- Kurt Flasch – Eva e Adamo. Metamorfosi di un mito – Il Mulino – 2007
- Jean Flori / Henri Rasolofomasoandro – Creazione o evoluzione ? – Edizioni ADV – 2005
- Roberto Fondi – La critica della scienza e il ripudio dell’evoluzionismo – in: “Testimonianze su Evola”, a cura di Gianfranco De Turris – Edizioni Mediterranee – 1985
- Roberto Fondi – Organicismo ed evoluzionismo. Intervista sulla nuova rivoluzione scientifica – Il Corallo / Il Settimo Sigillo – 1984
- Roberto Fondi / Giuseppe Sermonti – Dopo Darwin. Critica all’evoluzionismo – Rusconi – 1980
- Giorgio Renato Franci – Tanti tempi: alcune questioni indiane – In: I Quaderni di Avallon, n. 34, “Il senso del tempo” – 1995
- Carlo Frison – La comparsa dell’uomo secondo i miti sulle razze primordiali – Editrice La Bancarella – 1983
- Carlo Frison – La preistoria biblica, ovvero quando l’uomo perse una costola – Editrice La Bancarella – 1980
- Leo Frobenius – I miti di Atlantide – Xenia Edizioni – 1993
- Leo Frobenius – Storia delle civiltà africane – Bollati Boringhieri – 1991
- Pierre Fromentin – Gli uomini della preistoria – Massimo Milano – 1957
- Ciro Gardi – Gli americani si scoprono più antichi – in: Le Scienze – Maggio 1997
- Vito Genua – Antropogenesi e nozione di doppia creazione dell’uomo in Origene – in: Pan, vol. 23 – 2005
- Gaston Georgel – Le quattro Età dell’umanità. Introduzione alla concezione ciclica della storia – Il Cerchio – 1982
- Mario Giannitrapani – Arcana Naturae. Il mistero delle origini nella paleontologia umana – 25/10/2010 – Disponibile in rete sul sito dell’Associazione Simmetria; http://www.simmetria.org/simmetrianew/contenuti/articoli/45-scienza-sacra/264-arcana-naturae.html
- Mario Giannitrapani – Il destino dell’Uomo non è racchiuso nella spirale meccanicistica del Dna – L’Umanità dd. 22/11/1996
- Mario Giannitrapani – Paletnologia delle antichità indoeuropee. Le radici di un comune sentire (parte 1) – in: I Quaderni del Veliero, n. 2/3 – 1998
- Mario Giannitrapani – Paletnologia delle antichità indoeuropee. Le radici di un comune sentire (parte 2) – in: Quaderni di Kultur, n. 4 – 1998
- Mario Girardi – L’uomo immagine somigliante di Dio (Gen.1,26-27) nell’esegesi dei Cappadoci – in: Vetera Christianorum – fasc. 2 – 2001
- Vincenzo Giuffrida-Ruggeri – Su l’origine dell’uomo: nuove teorie e documenti – Zanichelli – 1921
- Georg Glowatzki – Le razze umane. Origine e diffusione – Editrice La Scuola – 1977
- Joscelyn Godwin – Il mito polare – Edizioni Mediterranee – 1993
- Enrico Goni – Nietzsche e l’evoluzionismo – Edizioni all’insegna del Veltro – 1989
- Joseph H. Greenberg / Merritt Ruhlen – Le origini linguistiche dei nativi americani – in: Le Scienze – Gennaio 1993
- Marco Grosso – I segreti della Luna nera – Edizioni Arktos – 2004
- Vinigi L. Grottanelli – Ethnologica. L’Uomo e la civiltà – Edizioni Labor – 1966
- Renè Guenon – Autorità spirituale e potere temporale – Luni Editrice – 1995
- Renè Guenon – Forme tradizionali e cicli cosmici – Edizioni Mediterranee – 1987
- Renè Guenon – Il Demiurgo e altri saggi – Adelphi – 2007
- Renè Guenon – Il Re del mondo – Adelphi – 1997
- Renè Guenon – Il Regno della Quantità e i Segni dei Tempi – Adelphi – 1995
- Renè Guenon – Il simbolismo della Croce – Luni Editrice – 1999
- Renè Guenon – La crisi del mondo moderno – Edizioni Mediterranee – 1985
- Renè Guenon – La Grande Triade – Adelphi – 1991
- Renè Guenon – Simboli della scienza sacra – Adelphi – 1990
- Renè Guenon – Studi sull’induismo – Luni Editrice – 1996
- Hans F.K. Gunther – Tipologia razziale dell’Europa – Edizioni Ghénos – 2003
- Graham Hancock – Impronte degli Dei – Corbaccio – 1996
- Charles H. Hapgood – Lo scorrimento della crosta terrestre – Einaudi – 1965
- Frank C. Hibben – L’Uomo preistorico in Europa – Feltrinelli – 1972
- Marcel F. Homet – I figli del sole – Edizioni MEB – 1972
- Giovanni Iammarrone – L’uomo immagine di Dio. Riflessioni su una spiritualità dell’immagine – in: Teresianum, A. 46, fasc. 2 – 1995
- Paul Jordan – Neandertal. L’origine dell’uomo – Newton & Compton Editori – 2001
- Karoly Kerenyi – Miti e Misteri – Bollati Boringhieri – 1996
- Karoly Kerenyi – Religione antica – Adelphi – 2001
- Richard G. Klein – Il cammino dell’Uomo. Antropologia culturale e biologica – Zanichelli – 1995
- Janusz K. Kozlowski – Preistoria – Jaca Book – 1993
- Heinrich Krauss – Il Paradiso – Donzelli Editore – 2005
- Bjorn Kurten – Non dalle scimmie – Einaudi – 1972
- L’uomo che viene dalla Cina – Sito Le Scienze – 15/1/2003; http://www.lescienze.it/news/2003/01/15/news/l_uomo_che_viene_dalla_cina-588640/
- La comparsa dei comportamenti “moderni” – Sito Le Scienze – 5/6/2009; http://www.lescienze.it/news/2009/06/05/news/la_comparsa_dei_comportamenti_moderni_-574697/
- La straordinaria diversità del melanesiani – Sito Le Scienze – 28/2/2007; http://www.lescienze.it/news/2007/02/28/news/la_strordinaria_diversita_dei_melanesiani-583318/
- Annabella Lampugnani – Il ciclo nel pensiero greco fino ad Aristotele. Evoluzione storica di un’idea e sue implicazioni teoretiche – La nuova Italia editrice – 1968
- Le impronte dei primi Americani – Sito Le Scienze – 6/7/2005; http://www.lescienze.it/news/2005/07/06/news/le_impronte_dei_primi_americani-584717/
- Victoria LePage – Shambhala. Il Paradiso perduto – Armenia – 1999
- Christophe Levalois – Il simbolismo del lupo – Arktos – 1988
- Christophe Levalois – La terra di luce. Il Nord e l’Origine – Edizioni Barbarossa – 1988
- Roger Lewin – Le origini dell’uomo moderno. Dai primi ominidi a Homo Sapiens – Zanichelli – 1996
- Martin Lings – Antiche fedi e moderne superstizioni – Il leone verde – 2002
- Paolo Lopane – Gnosticismo e Gnosi – in: Vie della Tradizione, n. 145 – Gennaio / Aprile 2007
- Silvano Lorenzoni – Chronos. Saggio sulla metafisica del tempo – Carpe Librum – 2001
- Silvano Lorenzoni – Il Selvaggio. Saggio sulla degenerazione umana – Edizioni Ghénos – 2005
- Jean Mabire – Thule. Il sole ritrovato degli Iperborei – Edizioni L’Età dell’Acquario – 2007
- Geraldine Magnan – Alla ricerca di Adamo – in: Scienza e Vita, n. 7 – Luglio 1998
- Paolo Magnone – I dadi e la scacchiera. Visioni indiane del tempo – in: I Quaderni di Avallon, n. 34, “Il senso del tempo” – 1995
- Alberto Malatesta – Geologia e paleobiologia dell’era glaciale – La Nuova Italia Scientifica – 1985
- Alessia Manfredi – L’uomo moderno arrivò prima. In Italia e GB resti più antichi – Sito La Repubblica – 2/11/2011; http://www.repubblica.it/scienze/2011/11/02/news/uomo_moderno_europa_44mila_anni_fa-24295476/
- Teresa Mantero – La demonologia nella tradizione greca – Tilgher – 1974
- Giorgio Manzi – Homo sapiens – Il Mulino – 2006
- Rocco Manzi – Evoluzione o creazione ? – Laurenziana – 2004
- Vittorio Marcozzi – L’uomo nello spazio e nel tempo – Casa Editrice Ambrosiana – 1953
- Vittorio Marcozzi – Trasformazione progressiva o regressiva nella famiglia umana ? – in: La scuola cattolica – Marzo/Aprile 1951
- Bruno Martinis – Continenti scomparsi – Edizioni Mediterranee – 1994
- Meister Eckhart – Commento alla Genesi (a cura di Marco Vannini) – Marietti – 1989
- Giovanni Monastra – Le origini della vita – Il Cerchio – 2000
- Giovanni Monastra – Natura archetipica: vincoli morfologici e gerarchici in biologia – in: Avallon, n. 56 “Seppellire Darwin ?”, anno 2007
- Claudio Mutti – Gentes. Popoli, territori, miti – EFFEPI – 2010
- Claudio Mutti – Hyperborea – in: Vie della Tradizione, n. 125 – Gennaio/Marzo 2002
- Claudio Mutti – Il simbolismo dell’Orso nelle culture artiche – in: Vie della Tradizione n. 16 – ottobre/dicembre 1974
- Claudio Mutti – Teofanie vegetali presso i Finni del Volga – in: Vie della Tradizione n. 17 – gennaio/marzo 1975
- Seyyed Hossein Nasr – L’uomo e la natura – Rusconi – 1977
- Steve Olson – Mappe della storia dell’uomo. Il passato che è nei nostri geni – Einaudi – 2003
- Stephen Oppenheimer – L’Eden a oriente – Mondadori – 2000
- Elaine Pagels – Adamo, Eva e il Serpente – Mondadori – 1990
- Raffaello Parenti – Lezioni di antropologia fisica – Libreria Scientifica Giordano Pellegrini – 1973
- Antonella Parisi – Un Sapiens poco moderno – in: Sapere – Giugno 1990
- Jacopo Pasotti – Ritmo doppio per l’evoluzione ai tropici – in: Le Scienze – Giugno 2006
- Rosalba Piazza – Adamo, Eva e il Serpente – La Luna – 1988
- Claudio Pogliano – L’ossessione della razza. Antropologia e genetica nel XX secolo – Edizioni della Normale – 2005
- Mario Polia – Il mistero imperiale del Graal – Il Cerchio – 1996
- Mario Polia – Imperium. Origine e funzione del potere regale nella Roma arcaica – Il Cerchio – 2001
- Franco Prattico – Eva nera – Codice Edizioni – 2007
- Franco Prattico – La tribù di Caino. L’irresistibile ascesa di Homo Sapiens – Raffaello Cortina Editore – 1995
- Giorgio Pullè – Razze e nazioni – CEDAM – 1939
- Daniel Raffard de Brienne – Per finirla con l’evoluzionismo. Delucidazioni su un mito inconsistente – Il Minotauro – 2003
- Fabio Ragno – Iniziazione ai Miti della Storia. Frammenti di una storia perduta – Edizioni Mediterranee – 1999
- Jean M. Riviere – Kalachakra. Iniziazione tantrica del Dalai Lama – Edizioni Mediterranee – 1988
- Philip Ross – Glottologi a confronto – in: Le Scienze – Giugno 1991
- Merritt Ruhlen – L’origine delle lingue – Adelphi – 2001
- Michele Sarà – L’evoluzione costruttiva: una nuova idea d’evoluzione – in: Avallon, n. 56 “Seppellire Darwin ?”, anno 2007
- Leo Schaya – L’uomo e l’assoluto secondo la Cabala – Rusconi – 1976
- Giuseppe Schiavone – L’Androgino tra realtà e mito – Bastogi – 1997
- Frithjof Schuon – Dal divino all’umano – Edizioni Mediterranee – 1993
- Frithjof Schuon – L’esoterismo come principio e come via – Edizioni Mediterranee – 1997
- Frithjof Schuon – L’uomo e la certezza – Borla – 1967
- Frithjof Schuon – La tradizione dei pellirosse – Ar – 1993
- Frithjof Schuon – Le stazioni della saggezza – Edizioni Mediterranee – 1983
- Frithjof Schuon – Sguardi sui mondi antichi – Edizioni Mediterranee – 1996
- Scienziati russi smentiscono ufficialmente la teoria dell’Out of Africa – 28/10/2016; https://lupobianco14org.wordpress.com/2016/10/28/scienziati-russi-smentiscono-ufficialmente-la-teoria-dellout-of-africa/
- Luca Sciortino – Le date dell’evoluzione – in: Le Scienze – Novembre 2004
- Luca Sciortino – Una grotta per due – in: Le Scienze – Ottobre 2005
- Stefano Serafini (a cura) – Atrium, numero speciale sull’evoluzionismo – anno IX (2007), numero 1
- Giuseppe Sermonti – Dimenticare Darwin. Ombre sull’evoluzione – Rusconi – 1999
- Giuseppe Sermonti – La Luna nel bosco. Saggio sull’origine della scimmia – Rusconi – 1985
- Giuseppe Sermonti – Le forme della vita. Introduzione alla biologia – Armando editore – 1981
- Rutilio Sermonti – Evoluzionismo: scienza o frode ? – Scripta manent diffusione libraria – 2005
- Rutilio Sermonti – Rapporto sull’evoluzionismo – Il Cinabro – 1985
- Jean Servier – L’uomo e l’invisibile – Borla – 1967
- Roberto Sicuteri – Lilith, la luna nera – Astrolabio – Ubaldini – 1980
- Lario Sinigaglia – La falce di Crono. La separazione tra maschio e femmina nel mito greco – Armando Editore – 2009
- Carlo Splendore – Teocosmogonia secondo la Gnosi – in: Vie della Tradizione, n. 124 – Ottobre/Dicembre 2001
- Giancarlo Stival – Peccato originale e miti greco-romani – in: Sacra Doctrina, vol. 5, anno XXXI – Settembre/Ottobre 1986
- Christopher B. Stringer – La comparsa dell’uomo moderno – in: Le Scienze – Febbraio 1991
- Bryan Sykes – Le sette figlie di Eva. Le comuni origini genetiche dell’umanità – Mondadori – 2003
- Angelo Tartabini / Francesca Giusti – Origine ed evoluzione del linguaggio. Scimpanzè, ominidi e uomini moderni – Liguori Editore – 2006
- Ian Tattersall – Il cammino dell’uomo. Perché siamo diversi dagli altri animali – Garzanti – 1998
- Alan G. Thorne / Milford H. Wolpoff – Un’evoluzione multiregionale – in: Le Scienze, Quaderni, n. 73 “L’evoluzione dell’uomo” – Settembre 1993
- Bal Gangadhar Tilak – La dimora artica nei Veda – ECIG – 1986
- Luca Valentini – Eros e la distruzione della diade – in: Vie della Tradizione n. 148, gennaio-aprile 2008
- Henry V. Vallois – Le razze umane – Garzanti – 1957
- Gastone Ventura – Considerazioni storico tradizionali sul mito della Regina di Saba – Edizioni di Vie della Tradizione – 1996
- Jean-Pierre Vernant – Mito e Pensiero presso i Greci – Einaudi – 2001
- Felice Vinci – Omero nel Baltico. Saggio sulla geografia omerica – Fratelli Palombi Editori – 1998
- L.M.A. Viola – Israele, Cristo e Roma. Mistero di Israele e Mistero di Roma. Escatologia universale e Regno Divino – in: Saturnia Regna, n. 42, 2005 – Victrix
- L.M.A. Viola – Religio Aeterna, vol. 2. Eternità, cicli cosmici, escatologia universale – Victrix – 2004
- L.M.A. Viola – Tempus sacrum – Victrix – 2003
- Nicholas Wade – All’alba dell’Uomo. Viaggio nelle origini della nostra specie – Cairo Editore – 2006
- Spencer Wells – Il lungo viaggio dell’uomo. L’odissea della nostra specie – Longanesi – 2006
- Colin Wilson – Da Atlantide alla Sfinge – Piemme – 1997
- Herman Wirth – Introduzione a “L’aurora dell’umanità” – EFFEPI – 2013
- Kate Wong – L’alba della nostra mente – in: Le Scienze – Agosto 2005
- Harun Yahya – L’inganno dell’evoluzione – Edizioni Al Hikma – 1999
- Gabriele Zaffiri – Alla ricerca della mitica Thule – Editrice La Gaia Scienza – 2006
- Marco Zagni – Archeologi di Himmler – Ritter – 2004
- Ubaldo Zalino – Cosmologia e evoluzionismo – in: Rivista di Studi Tradizionali, n. 35, luglio-dicembre 1971
- Pietro Paolo Zerafa – Antropologia biblica – in: Angelicum, vol. 80, fasc. 2 – Aprile/Giugno 2003