In vista dell’anniversario di nascita di Shirley Jackson pubblichiamo questa retrospettiva letteraria delle principali opere della scrittrice californiana, da L’incubo di Hill House a La lotteria, da La meridiana a La strega, concludendo con Abbiamo sempre vissuto nel castello.
di Paolo Mathlouthi
Capita sempre più spesso anche dalle nostre parti che gli scrittori protagonisti della felice stagione dei weird tales o penny dreadfuls che dir si voglia, ovvero le pubblicazioni periodiche che, a cavallo tra la fine XIX secolo e la prima metà del Novecento, hanno fatto la fortuna della letteratura dell’Orrore nel mondo anglosassone, vengano riscoperti da editori coraggiosi e poco inclini alle mode dettate dalla preconfezionata industria culturale e conoscano un’inattesa seconda giovinezza.
Se Abraham Merritt (1884-1943), esploratore di ipogee civiltà sdoganato dalla palermitana casa editrice Il Palindromo che, grazie alla meritoria opera di Andrea Scarabelli, ha riproposto nel 2018 Il vascello di Ishtar, torna oggi a far bella mostra di se nel catalogo Mondadori con due titoli irrinunciabili come Brucia strega, brucia! e Striscia, ombra!, alla profetica profondità di visione e al virtuosismo letterario davvero non comune della geniale Camilla Scarpa va ascritto il merito di aver da poco strappato all’oblio e tradotto un piccolo gioiello del genere gotico come La casa e il cervello di Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), chiamato a nuova vita per i tipi della milanese Aspis in una preziosa edizione a cura di un lovecraftiano di rango come Pietro Guarriello.

Una sorte per molti versi affine, pur nella diversità di toni e altezze, è quella occorsa nelle patrie lettere a Shirley Jackson (1916-1965). Casalinga disperata che nell’esercizio della scrittura di racconti neri brevi, fulminanti e angosciosi ha trovato una valvola di sfogo alla depressione cronica corroborata dall’abuso di alcolici e psicofarmaci, succedaneo necessario all’amore burrascoso e tormentato per Stanley Edgar Hyman, docente universitario e critico paludato che della talentuosa moglie è stato aguzzino e mentore insieme, ha occupato per lungo tempo una posizione marginale per non dire rapsodica nel panorama editoriale di casa nostra, benché godesse in patria di una certa notorietà, conquistata attraverso un’assidua collaborazione alle pagine culturali del “Newyorker”.
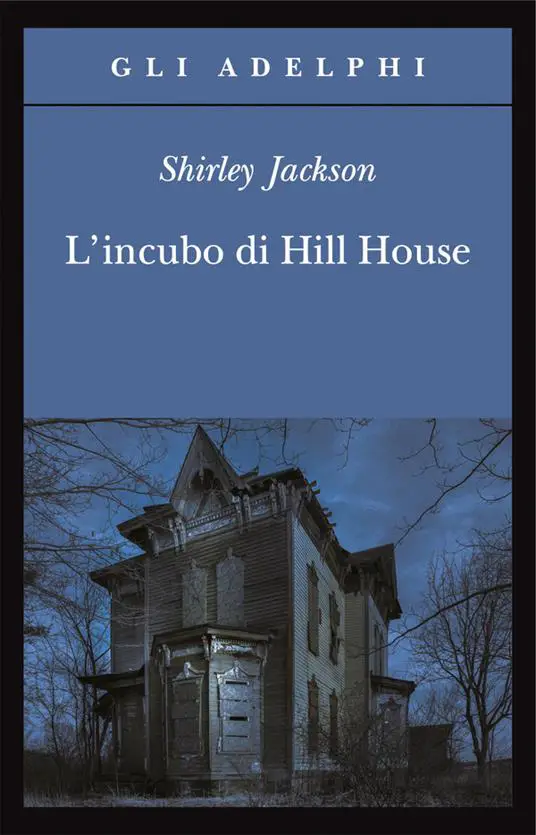
A segnare il cambio di passo nella ricezione della sua opera da parte dei lettori italiani è stato, ancora una volta, il compianto Roberto Calasso che, con la proverbiale, infallibile preveggenza per la quale è famoso, nel 2004 ha ripubblicato nel catalogo Adelphi L’incubo di Hill House, tenendo a battesimo la riscoperta di una scrittrice altrimenti ignota al grande pubblico. Va detto, ad onor del vero (e spero non me ne vorranno i suoi molti estimatori odierni), che il titolo scelto per inaugurare questo fortunato revival non è di sicuro tra i più rappresentativi della Jackson. Meccanismo narrativo perfettamente congegnato dal punto di vista formale, il romanzo, che pure vanta un paio di celebri trasposizioni cinematografiche e ha fatto da motivo conduttore ad una rinomata serie televisiva, ripropone il tema, assurto al rango di vero e proprio mantra da Edgar Allan Poe in avanti, della dimora maledetta dotata di una sinistra coscienza nella quale i malcapitati ospiti restano loro malgrado intrappolati come in un sepolcro. Le situazioni descritte peccano, a mio modesto parere, di eccessivo manierismo e il protagonista, l’antropologo John Montague, assomiglia troppo da vicino ad altri celebri indagatori dell’Occulto suoi predecessori, come Martin Hesselius e John Silence, perché la lettura possa risultare davvero convincente fino in fondo e suscitare, in chi si avventura tra queste pagine, un senso di autentica, perturbante apprensione [1].
Se l’Orrore puro, inteso cioè in un’accezione sovrannaturale e metafisica, non è esattamente nelle sue corde, per contro Shirley Jackson è bravissima nello svelare, direi per esperienza diretta maturata sul campo, quelli che Henry David Thoreau avrebbe chiamato gli abissi di quieta disperazione che si celano dietro il paravento di una condotta di vita apparentemente anonima ed irreprensibile, come accade, ad esempio, nel racconto La lotteria. A fare da sfondo alla narrazione è in questo caso una località imprecisata sperduta nelle insondabili vastità dell’immensa provincia americana. Protagonista una comunità di contadini laboriosi e timorati di Dio che una volta all’anno, sul finire del mese di giugno, si radunano in pubblica piazza per estrarre a sorte il nome di un proprio compaesano che viene letteralmente lapidato a scopo apotropaico, perché gli abitanti ritengono che la sua morte possa propiziare la buona riuscita del raccolto.

Riaffiora, trasfigurato in forma di apologo, l’archetipo del capro espiatorio che con ogni probabilità la Jackson, cresciuta in un contesto educativo rigidamente confessionale, ha mutuato dall’episodio biblico di Isacco, il quale di buon grado si presta ad essere immolato al Signore per mano di suo padre Abramo (Genesi, 22). Secondo René Girard, che all’argomento ha dedicato due saggi di capitale importanza, specie nelle società premoderne – e quella descritta dalla Jackson lo è senza dubbio nelle dinamiche sotterranee che la animano – l’uccisione rituale di una vittima innocente come Tessie Hutchinson serve, sul piano simbolico, a sviare la violenza che governa i rapporti sociali canalizzandola su un bersaglio inerme la cui morte, non rivendicata perché ritenuta in qualche modo indispensabile al mantenimento dell’ordine costituito, è finalizzata a rinsaldare la coesione tra gli appartenenti alla comunità e parimenti riveste un significato salvifico, poiché il sangue versato monda il consesso umano dalle sue colpe. Precisa Girard:
Gli uomini in gruppo sono soggetti a variazioni repentine nei loro rapporti, nel bene e nel male. Se attribuiscono un ciclo completo di variazioni alla vittima collettiva che facilita il ritorno alla normalità, dedurranno necessariamente da questo duplice transfert la credenza in una potenza trascendente, una e duplice allo stesso tempo, che reca loro alternativamente la dannazione e la salvezza, il castigo e la ricompensa. Questa potenza si manifesta tramite violenze delle quali è la vittima, ma ancora di più l’istigatrice misteriosa.
[2]
Una dialettica che, nel corso dei secoli, ha governato tutte le forme di persecuzione della Storia: il mito di Salem eternamente si rinnova. È la violenza infatti, in ultima analisi, il filo conduttore degli scritti della Jackson. Un impulso primordiale che cova sotto la cenere, imbrigliato dai vincoli e dai divieti della vita di relazione, che occasionalmente riaffiora in superficie, spezza il cerchio delle convenzioni e dispiega tutta la sua deflagrante forza distruttiva soprattutto laddove la nostra soglia di attenzione è più bassa in quanto riteniamo, razionalmente, di essere maggiormente al sicuro, ovvero nell’ambito del contesto familiare. Flannery O’Connor ha sentenziato a suo tempo che se si riesce a sopravvivere all’infanzia si ha materiale per scrivere per una vita intera. Lezione che la Jackson ha fatto propria con sottile maestria d’indagine psicologica, disvelando un microcosmo domestico improntato al principio della sopraffazione più bieca che preannuncia, nella sostanza se non nella forma, le cupe atmosfere evocate, ad esempio, da Truman Capote in A sangue freddo che, forse non a caso, viene dato alle stampe dal suo poliedrico autore un anno dopo la morte della scrittrice.

Nelle prose della Jackson i bambini sono testimoni oculari di un mondo degli adulti dalle marcate connotazioni freudiane che, lungi dall’essere protettivo ed accudente, incombe su di loro in forme mostruose. Se nel romanzo La meridiana è la giovanissima Fancy Halloran ad annunciare agli sbigottiti parenti, con il disarmante candore proprio della sua tenera età, che ad uccidere suo padre precipitandolo dalle scale è stata nientemeno che la nonna, disposta a sacrificare la vita dell’unico figlio maschio ed erede della casata pur di non doverlo condividere con l’odiatissima nuora, il piccolo protagonista del racconto La strega viene avvicinato sul treno da uno sconosciuto viaggiatore che, in maniera del tutto inaspettata e spiazzante per il lettore, alimenta la sua fervida fantasia con un terrificante aneddoto:
“Parlami di tua sorella – disse il bambino – era una strega?” “Può darsi” rispose l’uomo. Il bambino rise entusiasta e l’uomo si appoggiò allo schienale e tirò una boccata dal sigaro. “Tanto tempo fa” cominciò “avevo una sorellina, proprio come la tua”. Il bambino alzò lo sguardo su di lui, annuendo a ogni parola. “La mia sorellina” proseguì l’uomo “era così carina e simpatica che l’amavo più di ogni altra cosa al mondo. Allora vuoi sapere cosa ho fatto?”. Il bambino annuì con maggior foga, e la madre alzò gli occhi dal libro e sorrise, in ascolto. “Le ho comprato un cavallo a dondolo, una bambola e un milione di lecca-lecca” disse l’uomo. “Poi l’ho presa, le ho messo le mani intorno al collo e l’ho stretta, l’ho stretta finché è morta”.
[3]
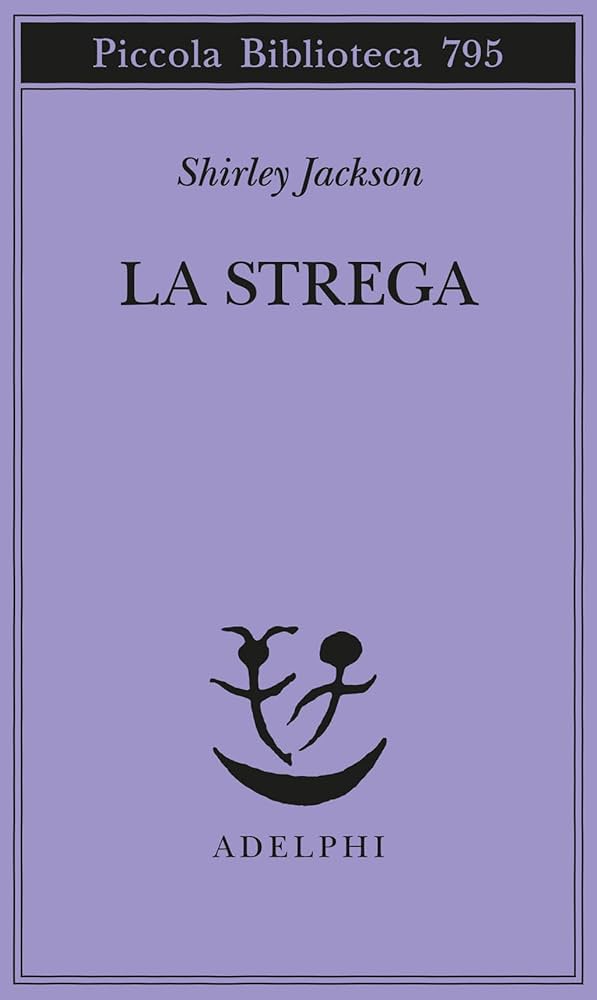
In un suo celeberrimo saggio, Bruno Bettelheim ha con acutezza osservato che il pensiero dominante ha espunto anche dalla letteratura destinata all’infanzia il tema della conflittualità, in favore di una narrazione orizzontale ed inclusiva, improntata ad una generica filosofia dell’autorealizzazione, la quale non corrisponde in alcun modo all’autentico universo psichico del bambino e quindi dell’uomo in divenire [4].
Shirley Jackson, al contrario, spinta dalla consapevolezza che il Male come la Virtù è onnipresente e che solo dall’osmotica ambivalenza tra le polarità opposte può scaturire la risoluzione dei conflitti interiori che ci dilaniano, ha recuperato la funzione arcaica e quindi autenticamente formativa della fiaba che è per tradizione intessuta di ombre. Nei suoi scritti l’Oscurità non solo esiste e pertanto bisogna essere adeguatamente preparati ad affrontarla, ma sprigiona un magnetico potere di seduzione che s’incarna in figure femminili dispotiche, anaffettive ed inequivocabilmente demoniche.

Mary Katherine Blackwood e sua sorella Constance, protagoniste del romanzo Abbiamo sempre vissuto nel castello, appaiono, a una prima superficiale indagine, come una coppia di zitelle acide e un po’ eccentriche, perché l’Autrice non rinuncia mai al gusto perverso di screziare una narrazione altrimenti angosciante con qualche nota di colore dal sapore farsesco, ma addentrandoci nella trama il contesto bucolico in cui è inserito il racconto cede progressivamente il passo alle tenebre e scopriamo che le nostre eroine sono in realtà due streghe, che trascorrono il proprio tempo a disseminare il perimetro della tenuta nella quale hanno scelto di segregarsi con amuleti utili a tenere lontani gli intrusi e gli spiriti dei defunti. Per giunta condividono l’insana passione di coltivare piante e funghi nocivi dai quali distillano potentissimi veleni, come quello usato per sterminare tutti i membri della loro famiglia e poter così preservare da indebite ingerenze il loro legame morbosamente incestuoso. La vicenda si chiude con gli abitanti del villaggio che, armati di torce e forconi, cingono d’assedio la magione delle sorelle Blackwood per consegnarla alle fiamme dall’abbraccio delle quali le due malcapitate usciranno miracolosamente illese, in una scena che, per enfasi drammatica, non può non richiamare alla mente i grandi roghi inquisitoriali del XVI e XVII secolo.
Sovvertendo con arguzia barocca l’impianto narrativo canonico del nostro patrimonio fiabesco, in un intreccio irriverente di situazioni sospese fra lo stralunato e lo scabroso nel quale potente vibra una nota di umorismo macabro, Shirley Jackson sposa il punto di vista di Grimilde e, nel delineare la fisionomia delle sue dame nere, riporta al centro della narrazione un archetipo, quello della donna che intrattiene commercio con il sovrannaturale, nel quale si riverbera quel dualismo irrisolvibile che sappiamo essere fondamento dell’ordine cosmico.

La Classicità ci ha d’altronde tramandato il ricordo delle due incantatrici per eccellenza, Circe e Medea, le quali, pur essendo sorelle, esattamente come Constance e Mary Katherine, incarnano tuttavia due modelli antitetici di femminilità. Se Circe, le cui pozioni regalano un oblio che smorza l’incalzare del tempo, è capace di commuoversi e di provare compassione, al punto da restituire la libertà a Ulisse e ai suoi compagni al momento propizio, Medea, al contrario, ordina, sottomette, folgora e si nutre letteralmente del cieco desiderio di vendetta che alimenta il suo furore di amante tradita. Entrambe figlie di Ecate, la triplice Dèa lunare che sovrintende al regno dei morti, è però Medea, secondo Ovidio, ad invocare la protezione della madre perché la assista nei suoi sanguinosi propositi:
O Notte, amica fedele dei misteri e voi, che con la Luna succedete alle luci del giorno, stelle dorate, e tu, Ecate dalle tre teste, che rispondi al mio appello per ricevere la confidenza dei miei progetti e per dar loro l’aiuto con il quale favorisci il canto e l’arte dei maghi, offritemi il vostro sostegno.
[5]
Gli fa eco Seneca, che accondiscendente, quasi complice, si presta a dar libero sfogo ai sinistri pensieri della sua paladina, la ritrae mentre parla con se stessa e si appella alle ombre silenziose, agli Dèi funebri, al cupo soggiorno del tenebroso Plutone e alle anime strappate ai bordi del Tartaro:
O fedeli complici delle mie opere, rivolgete ora la vostra collera e la vostra divina volontà contro le case dei nemici […]; datemi un male più atroce della morte da augurare al mio sposo.
[6]

Un livore sordo che si tramuta strada facendo in violenza iconoclasta e induce Medea a sacrificare la vita dei suoi stessi figli pur di privare Giasone di una discendenza legittima, proprio come accade alla decana di casa Halloran.
Sempre secondo Ovidio, Medea è anche la barbara avvelenatrice, che con la sua falce incantata miete piante terribili. Sa infatti servirsi di tutte le erbe della terra che all’occorrenza mescola con il veleno dei rettili aggiungendovi infine una goccia del proprio sangue: tutti elementi iconografici che transiteranno, pressoché invariati, nella simbologia medioevale, a costituire l’immagine stereotipata della strega così come è giunta a noi, con la sola non trascurabile eccezione che, essendo la voce degli antichi Dèi ormai indecifrabile alle nostre orecchie, le sue azioni sono poste sotto gli auspici di Lucifero. Scampata indenne alle persecuzioni, Medea si prende ora la sua meritata rivincita e rinasce “sotto nuove forme sopra il mondo mutato”, come avrebbe detto Novalis, trovando riparo tra le pagine della Jackson, celata appena dietro il velo della finzione letteraria.
NOTE
[1] Uscito in prima edizione nel 1959, L’incubo di Hill House ha conosciuto due trasposizioni cinematografiche. La prima è apparsa nelle sale americane nel 1963 con il titolo Gli invasati, per la regia di Robert Wise. Al 1999 risale invece la seconda versione realizzata da Jan de Bont con il titolo Haunting – Presenze, che vede nel cast Liam Neeson nei panni del Dottor Montague (alias David Marrow). Nel 2018 la casa di produzione Netflix ha realizzato invece una serie televisiva in dieci puntate intitolata The Haunting of Hill House, ideata e diretta da Mike Flanagan.
[2] René Girard, Il capro espiatorio, Adelphi, Milano 1987; p. 77. Sullo stesso argomento si raccomanda anche la lettura del saggio La violenza e il sacro, a firma del medesimo Autore, apparso sempre presso Adelphi nel 1980.
[3] Shirley Jackson, La strega, Adelphi, Milano 2023; pp. 14-15.
[4] Bruno Bettelheim, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, Feltrinelli, Milano 1984.
[5] Ovidio, Metamorfosi, VII, vv. 191-198.
[6] Seneca, Medea, vv. 740-751.
