L’11 aprile del 1989, 32 anni fa, ci lasciava lo scrittore inglese John WIlliam Wall, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Sarban, uno dei pochi scrittori itineranti della nostra era. Ricapitoliamo due sue opere che negli ultimi anni Adelphi ha pubblicato in italiano: il racconto “Zubrowka. Una storia di Natale” e il romanzo “Il richiamo del corno”.
di Paolo Mathlouthi
Copertina: Pieter Bruegel
Lo scrittore itinerante, ovvero colui che si serve del viaggio come spunto per dipanare nello spazio e nel tempo l’ordito e la trama della propria personalissima affabulazione sulle turbinose vicende di questo nostro vasto e strano mondo, è pervaso, direi quasi posseduto, da un’aerea febbre di vento, un’atavica propensione all’irrequietezza che gli è impossibile non assecondare. Non appena crede di aver messo radici, di aver trovato un porto sicuro nel quale riporre i resti dei propri naufragi, subito la smania di riprendere il cammino gli attanaglia il cuore e lo incalza, inesorabile. Ogni ritorno reca in dono i semi dai quali eternamente germoglia un nuovo viaggio, l’occasione per un altro inizio.
Chi non ha assaporato questa sensazione di mercuriale instabilità, assuefatto alla quieta disperazione di cui parla Thoreau nella quale la maggior parte di noi annaspa ogni giorno, non può capire. Quella del pellegrino narrante è una tipologia umana e letteraria ormai prossima all’estinzione: l’avvento della Tecnica, insieme feticcio e dannazione della Modernità, ha contratto i tempi e gli spazi, trasformando il viaggio nella semplice distanza tra due luoghi da consumarsi il prima possibile, un accadimento anonimo, del tutto privo ormai di quella dimensione iniziatica che, da Omero a Tolkien, ha nutrito di suggestioni la proteiforme fantasia di una stirpe di giganti.
Sopravvivono, è pur vero, alcuni solitari come Sylvain Tesson, Paolo Rumiz o Simon Winchester che nelle loro prose raminghe conservano ancora orgogliosamente intatto il sapore arcaico, desueto dell’andar per via. La loro è però una scelta estetica, una presa di posizione coraggiosa ma resiliente, quindi giocoforza inattuale, contraria allo spirito del tempo che si muove a tappe forzate in direzione opposta. Diversissimi per stile, sensibilità e coordinate culturali di riferimento, sono, forse loro malgrado, accomunati dal fatto di essere figli dispersi di una stagione irrimediabilmente perduta, quella delle grandi esplorazioni. Un’epopea iniziata cinque secoli orsono, in un’epoca di avventurieri, di vagabondi, di sradicati nostalgici che ha conosciuto il suo glorioso epicedio nel Novecento.
Un colorito caravanserraglio quello dei pionieri dell’Altrove, una corte dei miracoli nella quale personaggi picareschi degni di Lazarillo de Tormes, convinti di poter ottenere un riscatto personale da vite costellate di fallimenti attraverso imprese disperate in terre ostili e sconosciute che li hanno alla fine inghiottiti, convivono accanto a numi tutelari del calibro di Paul Morand, Patrick Leigh Fermor, Eric Ambler e Henry de Monfreid (solo per citare i più noti), rampolli della buona borghesia o dell’aristocrazia in declino che nel viaggio intravedono un succedaneo dell’azione, ultimo salvacondotto concesso per sfuggire al tedio della normalità ed esorcizzare l’assillo che, da inguaribili narcisisti quali senza dubbio sono, li consuma: l’anonimato, il timore di essere costretti a prendere commiato dal mondo senza aver fatto la differenza, incidendo una cicatrice sulla terra, come avrebbe detto Malraux.

Sono appunto l’amore per la lontananza, l’attrazione irresistibile per tutto ciò che sfugge all’ordinario, il desiderio spasmodico di assaporare la vertigine della vastità ad indirizzare John William Wall (1910 – 1989) verso la carriera diplomatica, una professione ancora circonfusa, agli albori del secolo scorso, di un’aura di avventurosa leggenda, che le deriva dai fasti eroici di Kipling e del Grande Gioco. Durante gli anni trascorsi a Cambridge, il giovane e promettente allievo rivela un orecchio particolarmente allenato alle criptiche sonorità delle lingue semitiche, pertanto, quando nel 1933, ancorché giovanissimo, diventa funzionario del Foreign Office, viene inquadrato nei ranghi del Dipartimento Arabo, lo stesso nel quale, tempo addietro, ha prestato servizio Thomas Edward Lawrence e, dopo una prima missione a Beirut, viene assegnato alla sede consolare di Jeddah, in Arabia Saudita.
Altre e più prestigiose mete seguiranno a quella remota destinazione durante una vita movimentata spesa in favore della Corona, ma l’incontro con il deserto, che a perdita d’occhio si espande in ogni direzione appena oltre le mura della città fino a toccare la linea dell’orizzonte, ha sul futuro scrittore l’effetto di una folgorazione: la rapinosa magnificenza dello sterminato mare di sabbia in cui, come recita il Corano, non s’immerge il remo, l’assordante, impenetrabile silenzio che lo avvolge, i cieli sconfinati che lo sovrastano, si scolpiscono in maniera indelebile nella sua memoria. Matura in lui la tormentosa consapevolezza di appartenere in qualche modo a quella desolata solitudine: sceglie per sé lo pseudonimo di Sarban, che in parsi significa carovaniere, pellegrino.
Tra le arroventate sabbie di quell’avamposto situato al limitare del Nulla ambienta il racconto Zubrowka, di cui Adelphi ha da poco proposto la prima traduzione italiana nella nuova collana “Microgrammi”, che apre la sua prima raccolta di scritti, Ringstones and others curious tales, apparsa nel 1951 presso l’editore Peter Davies, figlio adottivo (e sfortunato) di James M. Barrie, leggendario autore di “Peter Pan” il quale, cogliendo la stoffa da grande narratore che si cela dietro l’indole schiva e riottosa del diplomatico, ne asseconderà con certosina pazienza le bizze umorali e i saturnini estri, spesso e volentieri a scapito delle proprie tasche! Il lettore non si lasci trarre però in inganno dalle atmosfere assolate e meridiane che in questo divertissement fanno da cornice alla narrazione. Se avrà, come spero, la compiacenza di seguirmi, avventurandosi nel tortuoso labirinto delle sue fiabe crudeli, scoprirà con sorpresa che Sarban nulla concede al gusto dell’esotico tipico della letteratura d’Oltremare. La sua prosa è anzi umbratile, sotterranea, tellurica, spettrale, innervata da una sinistra vena creativa irresistibilmente sedotta dalle tenebre che avida si abbevera alla fonte di una magmatica, ribollente oscurità.
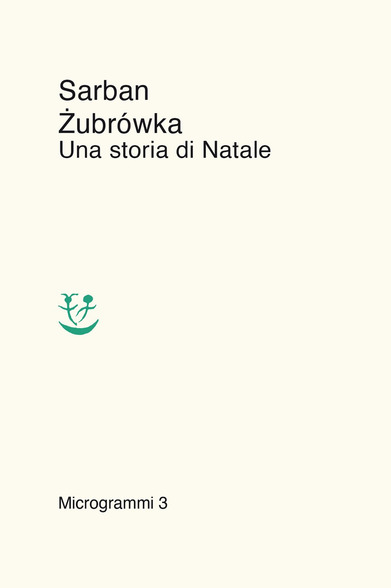
Accoccolato nel grembo di una notte sahariana calda e umida, Aleksandr Andreevic Masseev, ex ufficiale zarista riparato in Arabia con la moglie Lidija sotto la benevola protezione di Sua Maestà britannica per sfuggire ai furori iconoclasti della Rivoluzione, si abbandona al fluire dei ricordi e affida all’Autore, che di buon grado si presta al ruolo di confessore e voce narrante, le confidenze circa un episodio spaventoso occorsogli durante la guerra. Le dosi generose di vodka alle erbe che i due commensali ingollano noncuranti del clima soffocante hanno sul protagonista l’effetto di una madeleine: la sua mente si solleva dalle strade sabbiose della casbah librandosi verso altre latitudini e lo riporta indietro nel tempo a quel lontano giorno del 1917 quando, durante un volo di ricognizione lungo le coste della Siberia, a seguito di un’avaria al motore del suo idrovolante è costretto ad un atterraggio di fortuna nella taiga ricoperta da una spessa coltre di neve. Nel tentativo, rivelatosi presto vano, di raggiungere con l’ausilio di una bussola la stazione meteorologica di Kamennaja Gora per ricevere assistenza, Alksandr e il copilota Igor Paljaskin vengono fagocitati dalla tormenta. Si ritrovano di colpo sperduti in un paesaggio alieno, dal profilo lunare, in apparenza disertato da qualsiasi forma di umanità:
Potevamo vedere – riferisce il soldato russo nel suo allucinato monologo – in lungo e in largo l’immensa e triste taiga, quella piatta e solitaria landa desertica in cui ogni minima particella di vita era immobilizzata nella terribile morsa del Signore dei Ghiacci, mentre il suo corpo esanime continuava ad essere pugnalato dalle baionette del vento artico. E quando questo cessò sapevamo che un lenzuolo funebre sarebbe disceso dal cielo nero (…), la nebbia era un fantasma che fluttuava a cavallo del vento, celando ancora qua e là con il suo velo quel mondo inanimato. Non c’era buio né luce, ma un’indistinguibile mescolanza tra i due, come se la notte che si avvicinava fosse solo quella polvere di ghiaccio che ora la bufera ci soffiava addosso (…). Riuscivamo ad arrivare con lo sguardo fino alla fine del mondo, perché al mondo non c’era altro se non quella luce che non era più luce, quella terra incolore simile ai capelli di un cadavere. (1)
Un’immacolata desolazione nella quale i cacciatori samoiedi sembrano essere i soli capaci di sfidare l’ignoto e strappare brandelli di vita all’inclemenza di un inverno senza fine. Scivolando enigmatici e silenziosi sulla sconfinata distesa di neve con la leggerezza ovattata delle volpi, di cui hanno imparato ad imitare il passo, questi anacoreti ricoperti di pelli, superstiti di epoche dimenticate, si palesano all’improvviso sbucando dall’occhio del ciclone al cospetto dei due sbigottiti malcapitati, offrendo loro soccorso e riparo. Il fuoco di fronte al quale trovano ristoro non basta a dileguare le paure ancestrali che nell’abisso dell’interminabile oscurità artica s’impossessano di loro, anzi le amplifica a dismisura:
riuscivamo quasi a sentire la linfa strisciare lungo i piccoli abeti fino al suolo – racconta Aleksandr – e sapevamo che quella notte il Signore dei Ghiacci sarebbe venuto a trovarci nella taiga, a legare il fiume, spezzare i rami degli alberi e gelarci trasformandoci in pietre. (2)
La mattina dopo, mentre il piccolo drappello riprende la propria marcia in fila indiana alla volta dell’agognata destinazione, il demone evocato nel buio si manifesta con le sembianze di una bestia dalle dimensioni ciclopiche di cui i viandanti non riescono ad indovinare con precisione le fattezze che risoluta muove verso di loro:
il suono che sentimmo poco dopo ci fece gelare il sangue. Nell’orribile silenzio di morte udimmo qualcosa che si avvicinava in quel deserto senza uscita (…). Quale animale avrebbe mai potuto incarnare una simile forza, una così tremenda ostinazione? Un essere tanto maestoso e possente che nessun Dio ne aveva mai creato di uguale si trascinava nella palude. (3)
Un attimo prima di essere raggiunti, un provvidenziale squarcio si apre nella coltre di ghiaccio trascinando nelle insondabili profondità ipogee il mostro che invano si dibatte cercando di sottrarsi alla morte. Un’allucinazione? Un miraggio dovuto alle proibitive condizioni climatiche? Non lo sapremo mai, anche se, congedandosi, Aleksandr ammette, fissando il suo interlocutore negli occhi, di averlo intravisto per un istante.
Certo è che nei racconti di Sarban la Natura non conosce nessuna dimensione bucolica e non offre alcun riparo rassicurante tra le proprie braccia. Al contrario è una presenza incombente, panica, insinuante, ostile, dotata di una perversa volontà autonoma. Divinità sfrenata e selvaggia, sorda alle tribolazioni degli uomini, più matrigna che madre, famelica esige tributi di sangue, ridestando in loro istinti sopiti e costringendoli ad una lotta senza quartiere per aver salva la vita. Una lezione che Alan Querdilion, protagonista del romanzo Il richiamo del corno, impara a scapito della propria salute mentale.

Tenente della Royal Navy nel 1941 s’imbarca per andare a combattere i Tedeschi nell’Egeo ma la sua nave viene silurata a largo dell’isola di Creta e lui, fatto prigioniero, finisce internato in un campo di concentramento dell’Europa orientale dal quale riesce però fortunosamente ad evadere, cercando rifugio nel fitto della boscaglia dai suoi carcerieri che con teutonica meticolosità setacciano palmo a palmo la zona seguendone le tracce. Provato nel fisico dai lunghi mesi di detenzione e dalle privazioni subite, si trascina per giorni tra gli alberi che sembrano stringersi attorno a lui. Giunto in una radura viene investito da una luce abbagliante e cade a terra svenuto. Al risveglio si ritrova immerso nell’asettico candore di una stanza d’ospedale dove le infermiere, indaffarate e distratte, prestano scarsa attenzione alle poche frasi sconnesse da lui pronunciate nei rari momenti di lucidità concessi dai sedativi. Durante le interminabili ore notturne il silenzio ovattato dei corridoi è interrotto dal lugubre suono di un corno da caccia che si leva dall’intricata foresta situata al limitare della clinica:
Sembrava che il corno vagabondasse per i boschi battendoli avanti e indietro, lanciando il suo richiamo come alla ricerca di qualcosa, talvolta con incalzante ferocia, talvolta con una lunga e trattenuta nota di sconfitta. La notte era piena di rumori, la foresta insonne come l’oceano. Il vento squassava i faggi fuori dalla finestra, gli alberi conversavano in una moltitudine di lingue; l’intera orchestra del bosco suonava e il corno conduceva. Mi sembrava di sentire ogni sorta di voci e di strumenti in quella selvaggia conversazione, la mia immaginazione poteva trasformare il gemito dei rami ondeggianti nel guaito dei cani da caccia, e l’improvviso, sonoro stormire delle foglie che rabbrividivano al vento nello scalpiccio della loro corsa. Rimasi lì a lungo, in ascolto, (…) e sentii una strana agitazione montare dentro di me; non era più tristezza quella che sentivo, ma uno stato di angoscia e di apprensione, quel debilitante senso di pericolo che capita a volte di provare prima di capire da quale parte e da quale arma si è minacciati. (4)
Un turbamento che trova conferma nelle agghiaccianti rivelazioni del primario Wolf von Eichbrunn, il quale, al cospetto del suo paziente esterrefatto, dichiara, quando questi è abbastanza in forze da potersi reggere sulle proprie gambe, che la Germania ha vinto la guerra e sono trascorsi cento anni da quel fatidico giorno! Dopo un iniziale, comprensibile smarrimento, Alan desume di essere stato catapultato dalla misteriosa luminescenza che lo ha colpito nel corso della fuga dall’Oflag XXIX Z in una realtà alternativa alla sua, un universo parallelo dove le SS dominano incontrastate sul mondo. Circa l’origine della funerea eco che nottetempo riecheggia attraverso la coltre degli alberi, l’ufficiale britannico apprende dalle farneticanti elucubrazioni del dottore che si tratta del suono del corno con il quale il Conte Johann Hans von Hecklenberg, Gran Maestro delle Foreste del Reich, chiama i suoi illustri ospiti alla caccia attraverso l’immensa tenuta di sua proprietà, della quale anche la clinica è parte integrante: una diabolica giostra venatoria nella quale i prigionieri provenienti dai Paesi sottomessi, trasformati in grotteschi ibridi zoomorfi, vengono usati come selvaggina…
A quarant’anni di distanza dalla prima edizione italiana, pubblicata nel 1974 dall’editore Valentino De Carlo con il titolo fuorviante di Caccia alta, Roberto Calasso ha riproposto quello che è oggi considerato una sorta di libro per iniziati tra i cultori della letteratura dell’Orrore. Un piccolo capolavoro destinato ad inaugurare un filone, la distopia croceuncinata, oltremodo prolifico. Rispetto ad alcuni celebri epigoni quali ad esempio Fatherland di Robert Harris, Complotto contro l’America di Philip Roth o La svastica sul sole di Philip Dick, nei quali l’attinenza ai riferimenti storici che tratteggiano lo sfondo delle vicende raccontate obbedisce ad un principio di verosimiglianza se non di realtà, ancorché alterato ad arte in ossequio alle regole che scandiscono i meccanismi narrativi dell’ucronia, nelle pagine di Sarban si respira un’aria di rarefatta atemporalità, come se il dramma si consumasse al di fuori delle strettoie imposte dalla contingenza del divenire.

Lo scrittore sembra anzi rivolgere un occhio di riguardo alla dimensione archetipica, ai risvolti simbolici e onirici della trama, che sono per il lettore chiavi d’accesso ai territori inesplorati dell’Invisibile. Quando il protagonista, che diventerà a sua volta una preda di quella ferale moresca, viene condotto al cospetto di von Hacklenberg, gli si para dinnanzi una scena che potrebbe benissimo trovare posto in una tela di Pieter Bruegel o di Alfred Kubin:
l’uomo che sedeva là, dominando la tavola e tutto quel vasto salone, aveva nello sguardo qualcosa di barbaro che non avevo mai visto e che superava di gran lunga le mie fantasticherie. Non apparteneva né al mio secolo né a quello del dottore; ed era più lontano da quei volgari e chiassosi politicanti nazisti che gli stavano intorno di quanto loro non lo fossero da me. La loro brutalità era quella di una civiltà di massa, urbana e meccanizzata, la sordida crudeltà di una tirannia fatta di altoparlanti e mitra. Hans von Hacklenberg apparteneva a un’era in cui violenza e crudeltà facevano parte della persona, quando il diritto di un uomo a comandare risiedeva nella sua forza fisica; una così intima ferocia apparteneva al tempo degli Uri, i tori selvaggi di quell’antica e oscura foresta germanica che la Città non era mai riuscita a domare. (5)
Con buona pace di chi, spesso in malafede, ritiene che il Novecento sia un cimitero disseminato di relitti inservibili ed idee defunte, è innegabile che i grandi totalitarismi del Secolo Breve siano stati una fonte inesauribile d’ispirazione per gli scrittori che hanno indagato i diversi aspetti del Fantastico. Mentre gli utopisti negativi cresciuti all’ombra del Moloch sovietico come Evgenij Zamjatin e Stanislaw Lem che, animati da una concezione de facto progressiva della Storia e sostanzialmente fiduciosi nelle possibilità di palingenesi insite nella natura umana, danno corpo e sostanza alle loro ossessioni proiettandole in società avveniristiche e ipertecnologiche aduse ad esplorare gli spazi siderali, secondo i dettami estetici propri delle teorie cosmiste in voga oltre la Cortina di Ferro (6), Sarban, essendo nell’intimo un pessimista radicale al quale il presente sta stretto e nulla si attende dal futuro, per alimentare i suoi incubi attinge al pozzo di un passato senza memoria, torna alle radici del Mito. Alan Querdilion assiste, nella duplice veste di spettatore e vittima sacrificale, ad un ancestrale rito cannibalico nel corso del quale i gerarchi offrono libagioni umane al demone che, assiso su un trono di quercia nel cuore impenetrabile del suo tempio arboreo, propizia l’invincibilità del Reich. Un tenebroso genius loci che, guarda caso, porta il nome di una delle numerose personificazioni di Odino nelle vesti di Cacciatore Furioso (7).
Note:
[1] Sarban, Zubrowka. Una storia di Natale, Adelphi, Milano, 2020; pag. 39 – 40
[2] Ibidem; pag.32
[3] Ibidem; pag. 46
[4] Sarban, Il richiamo del corno, Adelphi, Milano 2015; pag. 54
[5] Ibidem; pag. 103
[6] Corrente di pensiero nata in Russia alla fine del XIX secolo sull’onda del successo riscosso dagli scritti di Nikolaj Fedorov, il Cosmismo era una filosofia di autorealizzazione che, conciliando le istanze più avveniristiche della scienza relative ad esempio alla manipolazione genetica del vivente con alcuni aspetti dello spiritualismo ortodosso, auspicava la rigenerazione dell’umanità che, liberata dall’assillo della morte, avrebbe poi colonizzato l’Universo. Curiosa sintesi tra scientismo positivista e tradizionalismo russo, oggetto di particolare interesse da parte del potere sovietico soprattutto durante il periodo delle esplorazioni spaziali, annoverava tra le sue fila alcuni tra i più riconosciuti maestri della fantascienza russa, come Aleksandr Bogdanov. Sull’argomento si veda George M. Young, I cosmisti russi, Tre Editori, Roma, 2017.
[7] Un’antica leggenda della Westfalia riferisce di un Conte Hans von Hacklenberg costretto a vagare in eterno alla testa di un esercito di anime senza requie per aver maledetto Dio poco prima di morire a seguito di una grave ferita infertagli da un cinghiale durante una battuta di caccia. Sulla sua identificazione con Odino si veda Giorgio de Santillana – Hertha von Dechend, Il Mulino di Amleto, Adelphi, Milano, 1983; pag. 287
