Dall’analisi delle due figure mitologiche del Puer Aeternus e della Kore nei misteri demetrici di Eleusi, negli studi dello storico delle religioni ungherese Károly Kerényi e nei commenti a questi di Carl Gustav Jung, emerge l’importanza del carattere “originario” e “fondativo” del mito greco, l’enigmatico nesso tra l’essere e il non-essere, quello tra la vita, l’amore e la morte che ci permettono di esprimere attraverso relazioni simboliche un processo cosmico in cui l’esistenza dell’uomo sia prossima alla realtà.
di Davide Simonato
tratto dall’elaborato di laurea “L’immagine dell’uomo nelle opere di Walter F. Otto, Károly Kerényi e Mircea Eliade“, 2014-15
copertina: Frederick Leighton, “Il ritorno di Persefone”
Il problema del non-essere secondo la visione religiosa dei greci era il tema del saggio posto come epilogo a Religione Antica, nel quale Károly Kerényi si spingeva al confronto con alcune delle posizioni più interessanti della filosofia contemporanea. All’idea nichilistica della morte intesa come un vuoto nulla, veniva contrapposta quella propria dell’antichità, secondo la quale essa era invece inclusa all’interno dell’orizzonte vitale, come limite che nell’oscurità custodisce il principio della vita [1].
È difficile allora non leggere i due successivi saggi di Kerényi come la logica prosecuzione di un discorso che, dopo quella simbolica conclusione, non sembrava essere destinato a proseguire. Incentrati sulla figura mitologica rispettivamente del bambino divino e della fanciulla divina, questi scritti diverranno celebri grazie alla loro successiva raccolta in volume, che comprende due ampli commenti di Carl Gustav Jung (1875-1961) [2] sugli archetipi psicologici corrispondenti. Al centro degli studi contenuti nel libro, che non si accordano in alcun modo all’altisonante titolo, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia [3], vi è la figura dell’Urkind, il fanciullo originario, analizzato tanto nel suo aspetto maschile quanto in quello femminile, ma soprattutto, come afferma Kerényi al termine del primo contributo, quale “eterno Indeterminato” [4].
Il fanciullo infatti, già nato eppure ancora in bilico fra la forma differenziata e terrestre e la figura eternamente indeterminata, ondeggiante sulle acque, è l’emblema dello stato di passaggio tra essere e non-essere. Collocato fra i due regni, più vicino ancora all’Aldilà che all’Aldiquà, esso partecipa di quei “modelli” in cui non è difficile riconoscere i simboli primordiali, gli archetipi [5]. L’archetipo ha per Kerényi la funzione di integrare il termine “umano” nel momento in cui l’uso tradizionale ne ha fatto un’espressione troppo vaga e generica. Riappare sotto altra forma il bisogno di recuperare il flusso vitale dell’esperienza vissuta e dei concreti valori umani, i modelli di condizioni eterne dell’esistenza [6].

La simbologia acquatica, caratteristica peculiare del mitologema del fanciullo, ritorna costantemente anche nelle pagine dell’Introduzione di Kerényi, intitolata Origine e fondazione della mitologia, importante momento di riflessione teorica. Bisognerebbe prendere e bere la pura acqua della sorgente perché questa ci compenetrasse e potenziasse le nostre latenti velleità mitologiche.
Eppure, anche qui c’è ancora molto che separa la bocca dall’orlo del calice. […] Noi abbiamo perduto l’accesso immediato alle realtà del mondo spirituale – ed a questo appartiene tutto ciò che vi è di autenticamente mitologico – anche a causa del nostro spirito scientifico fin troppo pronto ad aiutarci e fin troppo ricco di mezzi sussidiari. Esso ci aveva spiegato la bevanda nel calice, in modo che noi, meglio dei bravi bevitori antichi, sapevamo già in anticipo ciò che c’era dentro. […] Noi ci dobbiamo domandare se l’immediatezza dell’esperienza e del piacere di fronte alla mitologia ci è ancora in generale possibile [7].
Come scriveva citando un verso de I sonetti a Orfeo di Rilke, “Colui che si spande come una sorgente, viene conosciuto dalla conoscenza” [8]. Per quanto la finalità dichiarata sia proprio quella di trovare l’accesso alle realtà della mitologia, dove si trova questa sorgente? Il passo rilkiano citato proseguiva così: “e lo guida estasiato all’opera serena / cui l’inizio è una fine, spesso, e la fine inizio” [9]. Kerényi si mostra fiducioso della possibilità di cogliere i significati dell’opera, in questo caso mitologica, grazie alla compenetrazione tra soggetto conoscente ed oggetto: l’unico modo sembra essere quello di lasciar parlare i mitologemi – non potendoli più vivere – e prestare loro semplicemente ascolto. Infatti “la mitologia, come la testa recisa di Orfeo, continua a cantare anche dopo la sua morte, anche a lunga distanza dal tempo della sua morte” [10]. Così come la vita dell’uomo antico ritrovava la propria espressione e il proprio senso immergendosi nei modelli del passato,
La mitologia chiarisce se stessa e tutto quanto vi è nel mondo non perché essa sia stata inventata per spiegare, bensì perché essa ha la facoltà di chiarire [11].
I miti non spiegherebbero niente, in nessun senso, e mai: essi fissano un precedente che è ideale e garanzia del proseguimento [12].
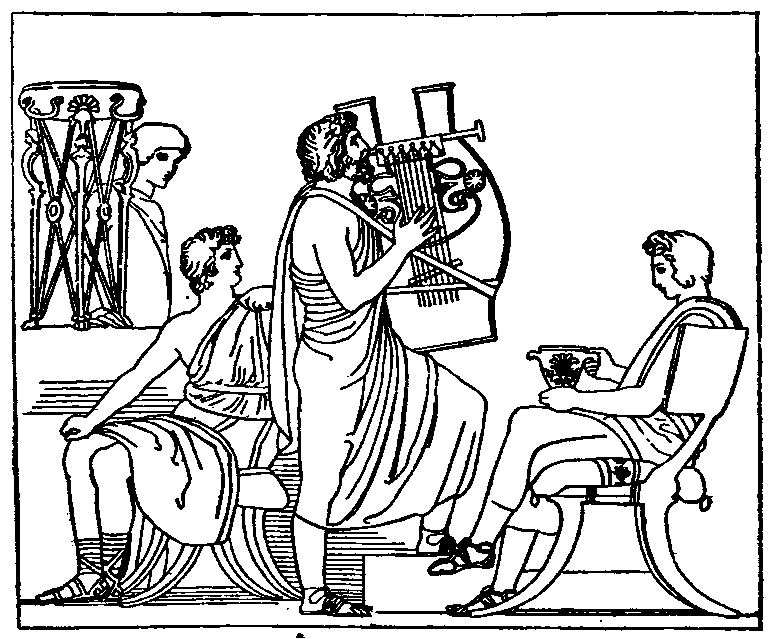
Lo scopo dei mitologemi sarebbe appunto quello di giustificare il mondo riportandolo al proprio fondamento, alle ἀρχαί, gli elementi primordiali, vitali ed inesauribili. La mitologia racconta sempre delle origini e ciò che è originario: per il narratore di miti questo equivaleva alla verità. In quale fondamento si ritrova l’uomo, la sua identità mitica per eccellenza, il punto di unità attorno al quale e a partire dal quale costruisce il proprio avvenire?
I due mitologemi […] servono ad indicarci attraverso le immagini del divenire umano e vegetale la strada su cui avviene la «fondazione» quale cammino alle ἀρχαί per rifare poi con noi la strada del suo esplicarsi in quelle immagini. Figurativamente si può parlare di un’immersione in noi stessi, che porta al vivo germe della nostra totalità. […]
Il «fondare» mitologico […] ha questo di paradossale: chi si ritira così in sé, si apre. O anche viceversa: l’essere aperto al mondo, caratteristica dell’uomo antico, pone questo sul suo proprio fondamento e gli fa riconoscere nella propria origine […] l’origine per eccellenza. Nell’immagine di un fanciullo divino, del primogenito dei primordi in cui per la prima volta si è verificata un’«origine», le mitologie non parlano del prodursi di un essere umano, ma di quello dell’universo divino o d’un dio universale. […] È il mondo che parla dell’origine nelle immagini che scaturiscono. Colui che in quella sommersione ha raggiunto il proprio fondamento, «fonda» il suo mondo [13].
Al mito delle origini corrisponde infatti un atto di altrettanto valore religioso e spirituale: la fondazione. Vivere il mito è come rifarsi alle proprie “origini”, ai propri elementi costitutivi e riorganizzarli sempre nuovamente. Come scriveva Jung a proposito del mandala, in un passo riportato da Kerényi al termine di una breve disamina dei miti di fondazione,
«Cose di questo genere non si inventano: esse devono riaffiorare sempre dalle profondità dell’oblio per esprimere gli estremi barlumi della coscienza e le più alte intuizioni dello spirito, e fondere in questo modo l’unicità della coscienza del presente con il passato primordiale della vita» [14].

La ricerca dell’origine non può che risolversi nel raccontare i modi di apparizione della medesima idea mitologica. Tramite una rassegna dei molteplici miti concernenti le grandi figure del fanciullo divino di varie mitologie – Apollo, Hermes, Dioniso, Giove, il dio dei Voguli, il Kullervo del Kalevala – con una vasta conoscenza di analogie e parallelismi nel campo etnologico, il primo saggio [15] persegue l’obiettivo di mostrare come questi presentino dei tratti così profondamente comuni da risultare come variazioni di un unico motivo: la forma infantile e atemporale del giovane quale pienezza di vita e di senso [16].
Lo scritto di Kerényi, evidenziando la natura tipica del mitologema, dava l’occasione a Jung di confermare la natura “archetipica” dello stesso, riprodotta nella sua struttura essenziale in situazioni storico-geografiche così diverse. Jung aveva infatti denominato “archetipi” (Archetypen) i contenuti dell’inconscio collettivo, le immagine appartenenti all’intera umanità, e l’indagine presentata dallo studioso ungherese poteva facilmente essere accostata alle sue conclusioni riguardanti l’esistenza di elementi strutturali mitopoietici [17]. L’indagine di Jung, arricchendosi di suggestioni che puntano decisamente verso altre direzioni, persegue comunque scopi ben diversi da quello di confermare i risultati di Kerényi [18].
Lo studio complementare dedicato a Kore indaga l’aspetto femminile del mitologema [19]: la divina fanciulla dei primordi contiene in sé, in forma involuta, le figure che più tardi assumeranno i nomi e le forme di Persefone, Hekate e Demeter. Questa divinità che è nascita, parto e morte allo stesso tempo, esistenza duratura e indistruttibile, esprime nella sua figura sia l’apertura al mondo che il racchiudersi in sé. Ad Eleusi si ritorna dunque al tema allegorico della linea divisoria che separa essere e non-essere. Kore e Persefone esprimono le due forme di esistenza femminile al loro estremo:
in un equilibrio in cui una di queste forme di esistenza (la fanciulla presso la madre), appare come vita, l’altra (la fanciulla presso l’uomo) come morte. Madre e figlia formano qui un’unità di vita in una situazione-limite: un’unità di natura che porta in sé, ugualmente per natura, la possibilità di spezzarsi [20].

Si alterna dunque la Kore, considerata unicamente sotto il suo aspetto più umano, ossia un essere che all’apice della vita inviolata cade vittima del destino, a Persefone, che rappresenta un destino che nel compimento significa morte e nella morte regalità [21]. Dopo la fanciulla e la sposa, la madre in lutto Demeter completa la triade di figure femminili, introducendo l’idea chiave dell’intero mitologema della fanciulla: la rinascita.
Entrare nella figura di Demeter, vale a dire essere perseguitati, derubati, anzi rubati, non comprendere ma adirarsi e rattristarsi, ma poi riavere e rinascere: che altro significa questo se non attuare l’idea più ampia dell’essere vivo, del destino dei mortali? Che cosa rimane qui per la figura di Persefone? Indubbiamente ciò che, oltre alla drammaticità senza fine del nascere e del morire, è inerente alla struttura degli esseri vivi: precisamente l’unicità (Einmaligkeit) del singolo essere, e la sua appartenenza alla non-esistenza. Unicità e non-esistenza – non concepite filosoficamente, bensì viste in figure o, per essere più esatti, l’ultima vista nell’amorfo, nel regno di Hades. È lì che regna Persefone – l’eterna-unica caduta nella non-esistenza [22].
Ancora una volta l’estrema attualità delle figure mitologiche trova la sua giustificazione nella capacità di esprimere attraverso relazioni simboliche un processo cosmico in cui l’esistenza dell’uomo sia prossima alla realtà. L’esperienza del culto è infatti al tempo stesso sia universale che singolare: l’evento vissuto porta il segno del divino e come tale viene raffigurato, per quanto esprima l’enigmatico nesso tra la vita, l’amore e la morte. L’iniziato non temeva di vivere tale paradosso. È noto il rapporto che i misteri eleusini intrattenevano con i culti agrari e più in generale con il ciclo della vita organica, e la conclusione del saggio ribadisce con forza questa unione tra il destino individuale e il mondo.
Il Greco era cosciente non tanto dell’«abisso» – l’«abisso del seme» – che gli si apriva in se stesso, quanto dell’esistenza in cui quell’abisso sfociava. La «serie infinita» significava qui appunto esistenza infinita: «esistenza» semplicemente. Si viveva questa, l’esistenza quasi come seme del seme, quale esperienza propria. Il sapere intorno a questa non diveniva pensiero discorsivo o parola. […] Contemplazione e contemplato, sapere ed essere, qui come anche altrove nel modo di pensare ed esistere dei Greci, si fondono in unità [23].
Un sapere senza parole esprimerebbe nel modo più eloquente la consapevolezza del proprio destino, proprio perché lo scopo perseguito non è formare un’opinione intorno ad un oggetto, ma giungere al suo stesso piano. Elevarsi al livello dei fenomeni accettando di mettere in discussione i principi prestabiliti è il compromesso per conoscere le possibilità di esistenza umana esplicate nelle figure mitologiche.

Note:
[1] Karl Kerényi, Religione Antica, cit., L’idea religiosa del non-essere [ed. or. Die religiöse Idee des Nichtseins, 1940], pp. 171-191. L’ultima edizione, da cui citiamo, colloca invece il saggio al centro del libro.
[2] Sul rapporto con Jung e la psicologia si veda Aldo Magris, op. cit., pp. 87 sgg. Sulla vicenda di questa pubblicazione in comune è importante qui segnalare come i lavori di Kerényi precedano i suoi contatti con Jung. Viene ugualmente da domandarsi se la vicinanza a Jung in qualche modo segua la stessa necessità di Mann nel suo confronto con Freud.
[3] Carl G. Jung – Károly Kerényi, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, Torino, Bollati Boringhieri, 1972 [ed. or. Einführung in das Wesen der Mythologie, 1941]. Il titolo italiano stona pure con quanto scrive Kerényi nelle prime righe dell’Introduzione (si veda infra): una più corretta traduzione sarebbe Introduzione all’essenza della mitologia.
[4] Cfr. Ivi, p. 106.
[5] Cfr. Furio Jesi, Letteratura e mito, Torino, Einaudi, 1981, p. 149.
[6] Cfr. Aldo Magris, op. cit, pp. 112-113.
[7] Carl G. Jung – Károly Kerényi, op. cit., Introduzione, pp. 13-14. Lo scritto si estende per le pp. 11-43.
[8] Cfr. Ivi, p. 17. “Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung.”
[9] “Und sie fuhrt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne, / das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.“ Die Sonette an Orpheus, Zweiter Teil, XII, in Rainer Maria Rilke, Poesie (1907-1926), a cura di Andreina Lavagetto, Torino, Einaudi, 2000, pp. 376-379.
[10] Carl G. Jung – Károly Kerényi, op. cit., p. 17.
[11] Ivi, p. 18.
[12] Ivi, p. 20
[13] Ivi, pp. 23-24.
[14] Ivi, p. 30. Corsivo suo.
[15] Ivi, Il fanciullo divino, pp. 45-106 [ed. or. Zum Urkind-Mythologem, 1938].
[16] Si veda anche Angelo Brelich, Recensione a C. G. Jung – K. Kerényi, Einfürung in das Wesen der Mythologie, «Studi e Materiali di Storia delle Religioni, XVIII, 1942, pp. 115-116.
[17] Chiarisco qui con una nota il concetto di archetipo secondo la concezione di Jung. Partendo dall’analisi dei sogni e delle psicosi dei suoi pazienti, Jung riscontrò come certe immagini, concetti e situazioni presentassero innumerevoli connessioni, che non trovavano confronto se non nelle associazioni di idee mitologiche. Esclusa l’ipotesi che si trattasse di cognizioni dimenticate, Jung pervenne alla supposizione che queste fossero reviviscenze autoctone indipendenti dalla tradizione. A differenza di Freud, che riteneva l’inconscio un contenitore vuoto alla nascita, riempito man mano di materiale psichico inaccettabile dalla coscienza, per Jung l’inconscio personale contiene già delle “forme a priori”, che fanno parte del cosiddetto “inconscio collettivo”, e che permettono di trascendere da se stessi, attraverso la funzione simbolica. Alcuni simboli hanno una ricorrenza universale, che rimanda all’esistenza di quelli che Jung chiama archetipi, cioè letteralmente modelli (come sottolinea lo stesso Jung l’espressione archetipo è la parafrasi esplicativa dell’eidos platonico e si trova già in Filone d’Alessandria con riferimento all’immagine di Dio nell’uomo). Gli archetipi non sono idee, ma possibilità di rappresentazioni, ossia disposizioni a riprodurre forme e immagini virtuali, tipiche del mondo e della vita, le quali corrispondono alle esperienze compiute dall’umanità nello sviluppo della coscienza. Essi si trasmettono ereditariamente e rappresentano una sorta di memoria dell’umanità, sedimentata nell’inconscio collettivo, e quindi presente in tutti i popoli, senza alcuna distinzione di tempo e luogo. Gli archetipi lasciano le loro tracce nei miti, nelle favole e nei sogni, che contrariamente a quanto pensava Freud, non sono appagamento di desideri puramente individuali legati alla sessualità infantile, ma espressioni dell’inconscio collettivo. Gli archetipi non si presentano mai all’analisi allo stato puro, ma attraverso loro manifestazioni in simboli: ogni individuo li avverte come bisogni e li può esprimere in modo storicamente variabile, secondo le diverse situazioni etniche, nazionali o familiari. In tal modo, l’inconscio collettivo, attraverso gli archetipi, può condizionare e dirigere la condotta dell’individuo nei suoi rapporti col mondo, inducendolo a ripetere esperienze collettive.
Si vedano gli studi contenuti in Carl Gustav Jung, Opere, 9. I. Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Torino, Boringhieri, 1980.
[18] Jung interpreta il fanciullo come simbolo della fase infantile ed embrionale dello sviluppo della psiche collettiva. Nella Kore invece leggerà la figura del «Sé» e l’«anima», l’elemento femminile presente anche nella personalità maschile.
[19] Carl G. Jung – Károly Kerényi, op. cit., Kore, pp. 149-220 [ed. or. Kore. Vom Mythologem des göttlichen Mädchens, 1939].
[20] Ivi, p. 160.
[21] Cfr. Ivi, p. 162.
[22] Ivi, pp. 180-181.
[23] Ivi, pp. 218-219.
.

5 commenti su “Il Puer e la Kore per Károly Kerényi: indeterminazione, origine e fondazione”